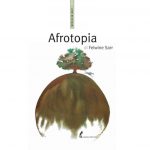Alla Scuola di specializzazione di Roma3, il Professor Manni, nei suoi sermoni liturgici sull’economia aziendale, era solito richiamarsi a uno dei fondatori di questa disciplina, vale a dire Gino Zappa, allievo di Fabio Besta, evidenziandone il metodo scientifico, nell’analizzare i fatti di gestione. Tale disciplina ha avuto la sua espansione a macchia d’olio, nei primi anni 90 del secolo scorso, quando gli ospedali vennero trasformati in aziende, le USL in ASL, quando il modello aziendalista incorporò tutti gli Enti del Terzo settore e inglobò le stesse famiglie nel modello di aziende di consumo. A completare il quadro, ci pensò la scuola pubblica, che rimodulò la docimologia sui crediti e sui debiti.
Il far di conto è un’attività che affonda le sue radici nel mondo antico e prende corpo là dove si presenta la necessità di misurare le transazioni commerciali. Nella divisione del lavoro assunsero importanza e prestigio sociale lo scriba in Egitto, il logista in Grecia e il rationale a Roma, ma le tecniche contabili fecero un notevole passo in avanti, quando nel Medioevo Leonardo Fibonacci sostituì i numeri romani con quelli arabi e in pieno Rinascimento, quando Fra’ Luca Pacioli formulò per la prima volta il metodo della partita doppia.
Ogni transazione, ogni fatto di gestione viene analizzato sia sotto l’aspetto economico che quello finanziario. I conti finanziari e quelli economici s’intrecciano tra di lor in modo sistematico e l’aspetto finanziario non è separato da quello economico. Qualsiasi acquisto genera un sacrificio, una variazione economica negativa che è misurata da una variazione finanziaria passiva, al contrario, qualsiasi vendita è un beneficio, una variazione economica positiva che è misurata da una variazione finanziaria attiva. Il ciclo economico è sfasato rispetto a quello monetario, pertanto sorgono debiti e crediti di regolamento.
Conti economici e finanziari confluiscono nel Bilancio, in prospetti diversi: nel Conto economico, la differenza tra le componenti positive del reddito d’esercizio e quelle negative corrisponde a un utile, un pareggio o una perdita. Fin qui il discorso segue il filo logico dell’algebra, la Ragioneria tende a misurare in modo preciso e neutro, non si vede il fine dell’azienda di produzione orientata al mercato, né tantomeno si percepiscono i rapporti di forza che caratterizzano le forme limitate e circoscritte degli scambi commerciali, nelle epoche storiche che precedono il modo di produzione capitalistico.
Ma qual è il fine istituzionale dell’azienda di produzione?
Il fine consiste nel conseguire il massimo profitto, mediante la produzione di beni e servizi destinati al mercato, la soddisfazione dei bisogni dei consumatori è secondaria, essa si verifica se e soltanto se si verifica la prima condizione, altrimenti la produzione non viene alla luce.
La molla che stimola la produzione è l’incremento del capitale proprio o di rischio, vale a dire la percentuale di utile non prelevata dagli azionisti e destinata all’autofinanziamento; la perdita invece è sinonimo del dissesto del capitale proprio.
Il fine suddetto, in Italia, divenne esplicito in un discorso di Gino Zappa nel 1926 all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e pubblicato nel 1927. In quel Manifesto vengono delineati i nuovi principi dell’economia aziendale, intesa dal Maestro come la scienza che studia le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita delle aziende.
Il merito di Gino Zappa è stato quello di fondere la Ragioneria, la Gestione e l’Organizzazione, nella sua visione le tre discipline s’ integrano a vicenda e interagiscono tra di loro; non sono altro che sottoinsiemi di quell’unico sistema che è l’azienda.
Il fine istituzionale coincide con quello aziendale: il valore degli esiti della produzione deve avere una funzione rigeneratrice, rispetto alle risorse impiegate. Gli innumerevoli discepoli del Maestro, all’ombra dello Stato sociale, contribuirono a diffondere l’idea che il perseguimento del massimo vantaggio di ciascuna azienda avrebbe avuto come conseguenza, non solo il miglioramento delle condizioni di esistenza di tutte le altre, ma anche dell’intera società.
In che modo si rileva il massimo vantaggio?
In base ai principi dell’economia aziendale, la differenza tra ricavi conseguiti e costi sostenuti è congrua, quando viene relazionata al capitale investito o agli investimenti alternativi.
Il rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi o di debito esprime l’indice di solidità aziendale e fa entrare in gioco, a sua volta, un altro indicatore sintetico: il leverage o leva finanziaria. Archimede affermò: «Datemi una leva e solleverò il mondo!».
Dalle aziende private a quelle pubbliche, sembra che l’indebitamento crescente abbia trovato terreno fertile, ma le relazioni tra gli indici di Bilancio, richiamano il vincolo: ci si può indebitare fino a quando il ROI è maggiore del ROD, cioè fino a che il ritorno del capitale investito è maggiore del costo medio del capitale preso a prestito.
Man mano che aumentano gli oneri finanziari, si riduce il risultato operativo e di conseguenza il reddito d’esercizio.
In base ai calcoli di convenienza economica, il rendimento del capitale proprio dev’essere equiparato con quello di altre aziende dello stesso settore o di settori alternativi e qualora non si prevedano sbocchi produttivi nell’economia reale o i rendimenti del capitale di rischio siano più bassi di quelli derivanti dagli investimenti finanziari, le scelte degli azionisti o dei singoli imprenditori ricadono sulla rendita finanziaria.
La remunerazione del capitale di rischio (profitto) e del capitale di terzi (oneri finanziari passivi), così come gli ammortamenti, gli oneri figurativi, concorrono a determinare il costo complessivo e quindi fissare il prezzo di vendita, per i consumatori finali.
E chi paga per i costi di ricerca e sviluppo e per quelli di Marketing?
La risposta è la stessa: i consumatori finali.
Per non parlare dei brevetti delle case farmaceutiche che fanno lievitare i prezzi a livelli esorbitanti, perdendo completamente il riferimento con i costi di produzione.
Dunque, per l’economia aziendale, la vendita di beni e servizi rappresenta la funzione rigeneratrice del valore, ossia la riproduzione delle condizioni di esistenza dell’azienda, ma tale certezza rimane ancorata al vantaggio monetario degli azionisti, all’incremento del capitale proprio.
Ma cos’è il capitale proprio e da dove deriva?
Il capitale proprio è vincolato all’azienda, richiama la proprietà del singolo o di più persone, la presenza di più soci rimanda alla formazione del capitale sociale. Agli scolaretti viene insegnato che 4 soci s’incontrano e decidono di costituire un’impresa, apportando denaro o beni in natura, tuttavia la trasformazione del denaro e dei mezzi di produzione in capitale è un processo storico, che non può essere banalizzato con un esercizio da manuale, campato in aria.
Infatti, se chiedete ai teorici dell’economia aziendale notizie sul come appare il gruzzolo iniziale, inizieranno a balbettare e sulla scia degli economisti classici, richiameranno il tempo mitico. Per spiegare questo passaggio, Marx, riprende il concetto di «previous accumulation» di A. Smith e lo collega con la parte che esprime il peccato originale nella teologia. Egli scrive, però, che «la leggenda del peccato originale teologico ci racconta come l’uomo sia stato condannato a mangiare il suo pane nel sudore della fronte; invece la storia del peccato originale economico ci rivela come mai vi sia della gente che non ha affatto bisogno di faticare».(1)
Succede poi che quei 4 giovani intelligenti, promettenti e risparmiatori diano vita a una start up e incontrino 4 sventurati, che hanno dilapidato i propri risparmi e quindi non gli rimane che vendere la propria forza lavoro, chiudendo il cerchio, per avviare il processo produttivo.
Il denaro o i mezzi di produzione iniziali, destinati (gettati) nel processo produttivo, diventano capitale, solo se si verifica una particolare condizione, precisa Marx, cioè la valorizzazione della proprietà apportata, conferita, mediante l’acquisto della forza lavoro altrui.
Nella mente dei sostenitori dell’economia aziendale, la separazione tra i lavoratori, da una parte, e dall’altra «la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro» (2) è data per scontata, è stata, in qualche modo, naturalizzata, nonostante le crepe e le crisi dei rapporti capitalistici, a cui essi assistono nel corso del tempo.
Il mito riappare, quando il proprietario di una catena di alberghi racconta che prima di diventare ricco, ha dormito per un periodo di tempo sotto un ponte di una città metropolitana, quando Berlusconi narra che si è fatto da sé ed ha iniziato come intrattenitore sulle navi da crociera oppure quando si legge che i fondatori di Apple Computer hanno iniziato in un garage e per finanziarsi, Jobs ha venduto il suo pulmino e Wozniak la sua calcolatrice, eccetera.
I nostri eroi carichi di adrenalina, una volta che sono investiti dal successo, che il capitale di “rischio” gli moltiplica i frutti, si scordano che comprano il lavoro dei salariati, di chi sgobba, per far funzionare le loro aziende, negano che dall’acquisto di forza lavoro traggono i loro profitti e negano soprattutto che nel processo di valorizzazione del capitale, a rischiare la pelle siano i lavoratori e le lavoratrici.
Non appena un’impresa chiude i battenti, sbaracca e investe in un altro luogo, i dipendenti finiscono sul lastrico, perdono temporaneamente le “catene del lavoro salariato”, confluiscono nelle maglie delle reti di protezione sociale, per poi ripresentarsi sul mercato del lavoro, in cerca di nuovi acquirenti.
E se gli acquirenti stentano ad impiegare la forza lavoro ridondante, significa che il lavoro necessario, per ottenere una determinata quantità di prodotti, è diminuito o meglio che è aumentata la produttività del lavoro ed esso viene espletato in un altro contesto.
Se osserviamo che molti dei prodotti, che utilizziamo quotidianamente in Italia, provengono dalle fabbriche cinesi o da altri paesi asiatici, allora bisogna accettare l’idea che tante lavoratrici e tanti lavoratori non trovino un’occupazione, ma anche che ci siano altre braccia a produrre, per soddisfare i bisogni dei consumatori.
Il lavoro è solamente sparito dalle scene del teatrino politico e sociale della Penisola italica e della vecchia Europa, un’operetta infestante a cui hanno contribuito in modo determinante i cultori dell’economia aziendale.
A rigor di logica, infine, se i 4 eccellenti galletti decidono di non assumere qualche scellerato, in quanto si presentano nelle vesti di imprenditori di se stessi, ben presto, scopriranno che se passano tutto il tempo a guardare il sole dove tramonta, senza effettuare nessuna attività lavorativa, la loro azienda andrà in malora e cadrà a pezzi.
1) K. Marx, Il Capitale, libro I, Sezione VII, Editori Riuniti, Roma 1980, p.777.
2) K. Marx, Ivi p. 778.