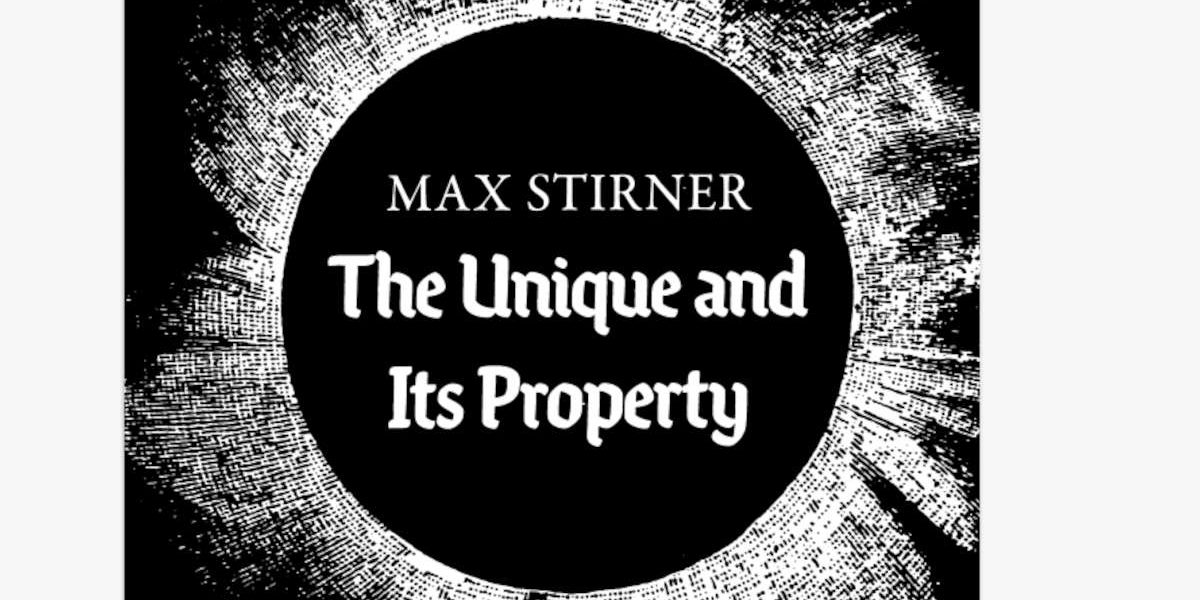1
A più di un secolo e mezzo dalla sua apparizione il fascino dell’Unico di Stirner è intatto. Le pagine più belle sono quelle del penultimo paragrafo – il cui titolo, nella traduzione inglese, suona come lo slogan della Coca Cola: MY SELF-ENJOYMENT.
L’uomo aspira a diventare qualcosa di diverso da ciò che è.
Ma che cosa? – chiede Stirner – forse aspira ad essere Buono, Bello, Vero?
L’uomo ha questo scopo nella vita: diventare giusto e grande – buono. L’uomo, dice Stirner, è il suo scopo, il suo dover essere, la sua destinazione, la sua missione, il suo compito, il suo ideale. L’uomo è per se stesso di là da venire. È un aldilà.
Non gli interessa il «Chi», dunque, ma il «Che cosa». Non l’unicità del «Chi», la sua ineffabilità e irripetibilità, ma l’esemplarità del «Che cosa». Egli non vuole il suo chi, il suo qui, il suo essere gettato – deietto. Aspira a diventare l’esemplare di una specie.
Non il singolo, dice Stirner, ma l’esemplare, l’ideale, è ciò a cui mira l’uomo, al quale il singolo non si rapporta neppure come il bambino all’uomo adulto, ma invece come un punto segnato col gesso al punto pensato o come una creatura finita al creatore eterno o, secondo le idee più recenti, come l’esemplare alla specie. Ecco allora l’esaltazione dell’«umanità», dell’umanità «eterna e immortale» per la cui gloria il singolo deve dar tutto se stesso, considerando suo «vanto imperituro» l’aver fatto qualcosa per lo «spirito dell’umanità».
Affinché diventi esemplare di una specie – la specie umana – il singolo deve svestirsi della sua unicità, deve spogliarsi del suo mondo e del suo essere-nel-mondo, deve marciare oltre ogni angoscia e tonalità emotiva, deve trascendere le sue miserie e condannare ogni sua voglia, e con esse tutto ciò che fa resistenza.
Questo aldilà, rispetto al quale ogni aldiqua è imperfetto e finito, è ciò che detta legge – è la legge stessa o la ragione.
La ragione, dice Stirner, è un libro pieno di leggi che si rivolgono tutte contro ciò che io stesso sono adesso, contro ciò che io voglio e desidero. Di più, rispetto a questa legge di ragione, dunque a questo modello, ogni aldiqua è un insulto, una imperfezione, un tradimento, un abuso – un crimine. Esistere è, per la ragione, un crimine, un affronto, una depravazione. E lo è, in quanto l’esistenza è finita, imperfetta, relativa. Mentre la legge – la ragione – è assoluta, perfetta, infinita, libera – libera da ogni brama, da ogni desiderio, da ogni concupiscenza.
Questo aldilà – l’assoluto della legge (il necessario) – è ciò verso cui l’esistenza deve tendere – è la sua causa finale, il suo dover essere.
In questo paragrafo Stirner riassume perfettamente tutta la sua tirata conto l’uomo e l’umanità, contro lo Stato, contro l’idea, contro la ragione, contro la legge, contro il bello, il bene, il male, il giusto, il comunismo, il socialismo, il liberalismo – contro ogni universale.
Si tratta di un uno splendido paragrafo contro la teleologia, paragrafo che bisogna avere il coraggio di meditare sino in fondo.
2
È sempre e dappertutto la stessa musica – dice Stirner. Se gli uomini fossero razionali, se tutti facessero ciò che è giusto, se tutti si lasciassero spingere dall’amore per il prossimo, se tutti fossero solidali, se tutti fossero razionali, eccetera, si raggiungerebbe lo scopo.
E qual è questo scopo?
Lo scopo è diventare umani. Essere umani.
Ma l’umanità cos’è?
L’umanità è un ideale. È un ideale che va oltre l’egoismo, oltre la sensualità, oltre il sensibile. È un ideale che va verso il sovrasensibile, verso l’intelligibile.
Ecco che, dice Stirner, l’uomo comincia a voler esser e diventare qualcosa.
Che cosa?
L’uomo vuole essere Buono, Bello, Vero. Egli vuole diventare un «uomo giusto», fare di sé «qualcosa di giusto e di grande». L’uomo è il suo scopo, il suo dover essere, la sua destinazione, la sua missione, il suo compito, il suo ideale. Egli è per se stesso di là da venire, un aldilà. Così, dice, comincia a guardare storto chi non riconosce lo stesso «che cosa», non ricerca la stessa moralità, non ha la stessa fede.
Eppure, dice, guardiamoci intorno, non c’è pecora né cane che si sforzi di diventare una «vera pecora» o un cane «un vero cane». Non c’è animale che veda la sua essenza come un compito, cioè come un concetto che deve realizzare. L’animale si realizza vivendo fino in fondo, cioè dissolvendosi, «passando», e non pretende di essere o di diventare qualcosa d’altro da ciò che è. Ciò che è va bene. Non c’è alcun metro con cui misurare la sua esistenza. L’esistenza è il metro di se stessa – come dire che non ci sono metri. Il modo in cui si esiste, ciò che si fa o non si fa, va sempre bene, è sempre giusto, è sempre bello. Non c’è un ideale al quale rapportare la condotta. L’esistente non ha uno scopo cui tendere, un fine verso cui dirigersi – nessuna missione, nessuna destinazione, nessun messianesimo, nessun sol dell’avvenire – qui non ci sono né Marx né Benjamin.
Voglio forse consigliarvi di diventare animali? – chiede Stirner.
Certamente no.
Perché si tratterebbe nuovamente di un compito, di uno scopo, di un ideale. E la teleologia, cacciata dalla porta, rientrerebbe dalla finestra. La vostra esistenza va bene così. Andate bene così come siete, non dovete sforzarvi di diventare qualcosa di diverso da ciò che siete, la vostra differenza, ciò che fa di voi stessi quello che siete, va bene, deve essere accettata così, per quello che è. Nessuno deve chiedervi di adeguarvi a un modello. Di rinunciare a quello che siete ora o siete diventati. Non dovete smussare gli angoli, cambiare qualcosa. Vi si deve tendere la mano nella differenza in cui siete piantati – non c’è bisogno di alcuna trascendenza. Non c’è un modello di ragione ragionevole, o di bellezza bella a cui adeguarsi o conformarsi. Così come siete, siete al massimo del vostro splendore – siete e vivete sempre al massimo della vostra potenza. E anche quando decidete di butterarvi giù, di imbruttirvi, di diventare abominevoli, bruttezza e abominio siete ancora voi. Nessun potrà dirvi che siete troppo grassi, o troppo magri, o troppo bassi, o troppo vestiti o troppi svestiti, o troppo bianchi o troppo neri, eccetera. Perché non c’è alcun criterio esterno, fisso, generico a cui commisurare la vostra differenza. Dal centro della propria differenza – della propria unicità – ognuno irradia la legge singolare (se mai fosse possibile) della sua propria unicità.
Un ideale e uno scopo, un fine ultimo, non sono altro che un aldilà al quale immolare la propria differenza. Un ideale di bellezza, un ideale di uomo – l’uomo bianco – un ideale di razionalità – la logica fisico-matematica – eccetera, sono un dover essere, uno scopo a cui sacrificare la propria esistenza e differenza, la propria unicità – un sacrificio che restituisce cosa?, se non un esemplare uscito da uno stampo col quale si vuol plasmare l’intera umanità.
Quali sacrifici non sono stati commessi sull’altare dell’ideale! Quanti sforzi ed esercizi e rinunce sono stati fatti per diventare simili a questo ideale!
Un animale addestrato, dice Stirner, non è migliore di un animale naturale. Un animale ammaestrato non ci guadagna nulla.
Allo stesso modo si è cercato di ammaestrare l’uomo, di renderlo più buono, più razionale, più umano, eccetera. Ma questi tentativi, dice, sono sempre naufragati contro lo scoglio della egoità indomabile, della natura propria, dell’egoismo.
L’uomo ammaestrato non raggiunge mai il suo ideale, rimane sempre un fondo di unicità o esistenza incorreggibile. Dunque, rispetto all’ideale di uomo devono sempre nella vita riconoscersi peccatori e restare sempre indietro rispetto al loro ideale, sono, dice, «uomini deboli» (schwache Menschen) e portano con sé la consapevolezza della «debolezza umana» (menschlichen Schwachheit).
Che cos’è questa debolezza se non anche pensiero debole (schwache Denken)?
3
Alla domanda «che cosa è» questo individuo «qui», il pensiero forte – ovvero la ragione – risponde che questo individuo è un uomo, un soggetto, e che questo soggetto è ciò che, in ogni individuo mutevole, non cambia, è ciò che permane, che rimane identico a se stesso. Rispetto all’accidentale il soggetto è ciò che necessariamente è – sostanza.
È necessario ciò che non può essere altrimenti, che non ha possibilità, che comprende tutte le possibilità – il semplice – che non può essere diversamente da come è – il vero.
Il vero è ciò che non muta, che vale per ciascun membro e in ogni circostanza.
Nella verità così concepita la storia e la sensibilità sono neutralizzate. La verità alloggia – se così si può dire – in un aldilà del mondo fisico. Abita in quel cielo dove niente può più determinarla e dominarla – dove può dimorare libera e sovrana. Verità, libertà e sovranità sono dunque sinonimi. Nessuna influenza terrestre può più estraniarla da se stessa. Le ceneri del mondo sono state gettate via e la lotta contro il mondo è ormai finita, dove quindi nulla più viene negato. La negazione determinata, dunque la determinazione, è cessata. Non si nega più niente, perché niente è più estraneo e avverso.
Non è per nulla sufficiente mettere a morte questo cielo – Dio – e riportare giù ciò che si era posto in alto, e sostituire Dio con l’Io, se questo io poi finisce per corrisponde al Cogito di Cartesio o all’io di Kant. Saremmo punto e a capo. Perché questo io – questo soggetto trascendentale – sarebbe ancora quell’aldilà di ogni esperienza e di ogni egoismo, e pertanto tale e quale a Dio.
In Kant l’io – il soggetto – non può essere un io psicologico, un io empirico, un io debole. Deve essere un io forte, necessario, libero da ogni condizione, dunque sovrano. Nella filosofia di Kant si replica la svalutazione del mondo sensibile a favore del mondo sovra-sensibile, la svalutazione della Terra a favore del Cielo.
Il sistema hegeliano, dice Stirner, sembrava aver superato la separazione tra sensibile e intelligibile, tra Terra e Cielo, tra necessario e contingente, come se in esso le parole e le cose celebrassero la loro riunione. Ma non si trattava per l’appunto, dice, che dell’estrema violenza del pensiero, della sua tirannia assoluta, del suo dominio esclusivo, del trionfo dello spirito e, con esso, del trionfo della filosofia. Gli hegeliani – gli uomini spirituali – si sono messi in testa, dice Stirner, qualcosa che deve essere realizzato. Essi hanno concetti dell’amore, del bene, eccetera, e li vorrebbero veder realizzati. Per questo vogliono costruire sulla Terra un regno dell’amore, in cui nessuno agisca più per interesse personale, ma tutti, invece, «per amore». Essi vogliono – pensate un po’ la violenza assoluta del progetto! – fare di ogni individuo un uomo, di ogni persona un’ape operaia, di ogni diverso un uguale, di ogni differenza una identità. Vogliono portare sulla Terra il regno dei Cieli. L’uguaglianza, la giustizia, l’amore devono regnare – devono dominarci. L’uomo – l’ideale -, dice Stirner, deve venire edificato in noi, anche se noi, poveri diavoli, dovessimo perirne, secondo il famoso fiat justitia, pereat mundus.
L’uomo e la giustizia sono idee, fantasmi, per amore dei quali si sacrifica tutto: per questo gli spiriti bigotti sono «pronti a sacrificarsi». Io non sono il mio corpo e la mia carne, io sono spirito, e la carne e il corpo sono ciò che deve essere abbandonato – sacrificato – per elevarsi alla perfezione spirituale dell’idea. L’uomo è un’idea – la giustizia è un’idea.
4
Due sono i temi che Stirner cerca di sottolineare. In primo luogo, il tema della teleologia. Quando chiedo a cosa serve la mano e la risposta è «La mano serve per afferrare», riassumo l’intera storia della metafisica con il suo implicito teleologismo. Se nella mano vedo uno scopo, un dover-essere, un fine verso il quale l’evoluzione si è indirizzata, implicitamente vedo la testa di un Creatore – Dio, Natura, eccetera, non fa differenza – vedo dentro la testa di un essere superiore – spirituale – il progetto, l’idea di mano, rispetto alla quale le mani particolari non sono altro che degli esemplari. Se, al contrario, dico che «La mano non serve a nulla», che è venuta fuori a caso, come frutto dell’errore o dell’erranza, e che anche la sua replica è casuale, metto implicitamente in discussione il concetto di origine, di principio, di libertà, di sovranità, eccetera. Non c’è alcun aldilà rispetto al quale l’aldiqua sarebbe una attualizzazione.
In secondo luogo, ma connesso direttamente con il primo, Stirner sottolinea il tema della differenza. Ogni esistenza è unica. Cosa vuol dire? Vuol dire che, di diritto – dunque apriori –, ogni esistenza è differente da tutte le altre.
Non essendoci alcun modello – alcuna idea, alcun dover-essere – ogni esistenza, per quanto assurda o violenta o stramba possa apparire ai nostri gusti, è legittima quanto le altre – anzi, dire che è legittima è già volerla ridurre a una legge, a un modello, ad un criterio di controllo. Ogni esistenza ha una storia a sé, tanto quanto ogni altra. Punto. Venendo meno la teleologia viene meno ogni criterio di valutazione, ogni metro, ogni modello, persino la storia, eccetera.
Non c’è un modello fisico di uomo, rispetto al quale gli uomini effettivi sarebbero esemplari più o meno riusciti – il bianco più del giallo, il giallo più del rosso, il rosso più del nero, eccetera.
La differenza non si limita al solo aspetto fisico. La differenza abbraccia anche il bene e il bello. Non c’è un comportamento che rappresenti il modello o l’ideale rispetto al quale tutti gli altri comportamenti sarebbero, più o meno, delle devianze – una contro-natura – eccetera. Il Pederasta o la Butch non sarebbero membri pervertiti del modello eterosessuale. Il dialetto non sarebbe lo stato primordiale o la regressione della lingua, il pensiero selvaggio non sarebbe uno stadio non strutturato del pensiero odierno, le nazioni barbare o aborigene non sarebbero lo stadio pre-civile della civiltà occidentale, il passato non sarebbe un esempio per il futuro, eccetera. Non c’è un racconto (récit) – il racconto, ci sono versione concorrenti, e altrettanto legittime, degli stessi fatti, ci sono mezze verità e panzane che aspirano e hanno lo stesso grado di legittimità di tutte le altre narrazioni.
Allo stesso modo il furto non sarebbe la ragione d’essere della proprietà privata, perché non c’è azione che, in base a un dover-essere, possa essere classificata come furto o come guadagno legittimo. Sin dove la mia mano giunge e arraffa, tutto è mio – più in là è ancora mio, solo che non ci arrivo.
Proudhon, dice Stirner, ritenendo che il furto sia senz’altro da aborrire, crede di aver bollato a sufficienza la proprietà, dichiarando che essa «è un furto». Quest’ultimo è, nella prospettiva bigotta, un delitto o, per lo meno, una mancanza. Ma la mia mano che, arrivata prima della tua, afferra il frutto, non commette alcun furto. E non ci sono ragioni che tengano a che il frutto vada diviso eccetera. Lo stesso dicasi per il frutto del proprio lavoro. Non sta scritto né in cielo né in terra che il frutto del lavoro ti appartiene di diritto.
L’uomo il cui diritto verrebbe violato non esiste, è un fantasma, un’idea, un dover esser, rispetto al quale gli uomini concreti sarebbero sempre nel torto.
La stessa cosa dicasi del bello. Non sei brutto perché sei basso, perché hai il viso asimmetrico, perché hai le gambe storte, perché hai i capelli lisci, o ricci, gli occhi piccoli, eccetera. Non c’è nessun modello, o, se questo modello c’è, esso è un fantasma, un’idea, un dover-essere, un aldilà messo a punto per squalificare l’aldiqua.
Ciò che la politica moderna, la morale moderna, l’estetica moderna – la filosofia moderna – mettono al bando sono gli interessi particolari e gli aspetti personali. Chiedono di sacrificarsi per un dover-essere. La propria persona va sacrificata: solo per l’ideale bisogna vivere.
Si deve agire in modo neutro, «disinteressatamente», si deve cercare non il proprio utile, non quello che va bene per sé, ma quello che va bene per tutti, che va bene per l’uomo. L’uomo, dice Stirner, è perciò diventato la vera persona, di fronte alla quale la personalità singola scompare: non io devo vivere, ma l’uomo in me. Di fronte a questo Dio, scompare ogni egoismo e davanti a lui tutti sono uguali: essi sono, senza alcun’altra differenza – uomini, nient’altro che uomini.
L’uomo non ha nessun riguardo per la mia persona. Io, come ogni altro, sono per lui soltanto un esemplare, senza alcun altro significato che in qualche modo possa imporglisi.
Gli inglesi, appesi all’uomo concreto, non sono mai diventati filosofi. La loro filosofia, dice Stirner, non ha mai saputo diventare teologica, diventar teologia, eppure solo come teologia la filosofia può vivere se stessa fino in fondo e giungere al suo compimento. La teologia è il luogo eletto per la sua agonia. Bacone non si curava di questioni teologiche e di punti cardinali.
Il cogito sum di Cartesio, dice Stirner, ha il senso seguente: si vive solo se si pensa. Vita pensante significa «vita spirituale». Solo lo spirito vive, la sua vita è la vera vita. Allo stesso modo poi, nella natura, solo le «leggi eterne», lo spirito o la ragione naturale sono la sua vera vita. Solo il pensiero, nell’uomo come nella natura, vive; tutto il resto è morto! Nella prospettiva della storia dello spirito è inevitabile giungere a quest’astrazione, alla vita dei concetti generali, che per la coscienza comune sono invece privi di vita. Solo Dio, che è spirito, vive. Soltanto gli spettri sono veramente vivi. L’età moderna si è limitata a trasformare gli oggetti esistenti in oggetti rappresentati, cioè in concetti.
Stirner arretra dell’idealismo all’empirismo.
5
Nell’Enciclopedia (§37) Hegel elogia l’empirismo, dice che esso invece di cercare il vero nel pensiero lo va a cercare nell’esperienza, da quel che è presente nella percezione interna e esterna.
Ciò cui Stirner punta è proprio l’esperienza. Nella realtà effettiva non si incontra mai l’uomo, o lo Stato, o il Sovrano, o la Libertà. Nella realtà effettiva si fa esperienza di questo uomo qui, che è diverso da quest’altro, e si fa esperienza di questa condizione qui, che mai può dirsi libera da ogni vincolo, perché ogni posizione suppone sempre un’opposizione, ogni amico suppone un nemico, ogni posizione suppone una negazione – la determinazione è negazione.
C’è nell’empirismo questo gran principio – dice Hegel (§38): che ciò che è vero, deve essere nella realtà ed esservi per la percezione. Questo principio è opposto al dover essere, col quale la riflessione si gonfia e prende atteggiamenti sprezzanti verso il reale e presente, adducendo un aldilà.
La verità, presentandosi con i caratteri dell’universalità e della necessità, non può essere esperita.
L’empiria, dice Hegel (§39), mostra molte, innumerevoli, percezioni eguali. Ma l’universale è qualcosa di affatto diverso dalla gran moltitudine. Ugualmente, l’empiria ci offre percezioni di cambiamenti successivi o di oggetti giustapposti; ma non già una connessione necessaria. Dovendo la percezione restare il fondamento di ciò che vale come verità, l’universalità e la necessità sembrano qualcosa d’ingiustificato, un’accidentalità soggettiva, una semplice abitudine, il cui contenuto può essere costituito così o altrimenti. Un’importante conseguenza che di qui deriva, è, che in questo modo empirico le determinazioni e le leggi giuridiche e morali, nonché il contenuto della religione, appaiono qualcosa di accidentale, e si rinuncia alla loro oggettività e alla loro intima verità.
Lo scetticismo di Hume, dice Hegel, pone a fondamento la verità dell’empirico, del sentimento, dell’intuizione; e, muovendo da essa, combatte i principi e le leggi generali, per la ragione che non si giustificano mediante la percezione sensibile.
Il criticismo di Kant, dice Hegel (§40), ha in comune con l’empirismo l’accettazione dell’esperienza come unico campo delle conoscenze; le quali per altro non sono considerate come verità, ma soltanto come conoscenze di fenomeni.
La filosofia critica, dice, prende le mosse dal distinguere 1) gli elementi che si trovano nell’analisi dell’esperienza, cioè la materia sensibile e 2) le relazioni universali della stessa.
Nella percezione per sé presa è contenuto solo il singolo e solo quello che accade. S’insiste insieme sul fatto che, in ciò che si chiama esperienza, si ritrovano, come caratteri egualmente essenziali, l’universalità e la necessità. E poiché questi elementi non derivano dall’empirico in quanto tale, essi appartengono alla spontaneità del pensiero, ossia sono apriori.
L’elemento apriori – l’universale e il necessario – si trova nel pensiero. Ma questo pensiero non è, e non potrebbe essere, il pensiero di un io psicologico, di questo uomo qui, in quanto l’io psicologico si pone sul terreno dei fatti, e su questo terreno, ancora una volta, si incontra il singolo, l’unico, e da quest’unico ci si aspettano cambiamenti successivi o oggetti giustapposti; ma non già una connessione necessaria. Sul terreno dei fatti e della psicologia si trovano sempre mezze verità. Su questo terreno il sapere è preso sempre nelle spire di un sapere-potere.
Non c’è sapere che non sia l’espressione di un potere – questo è il terzo tema del discorso di Stirner. Al quale si aggiunge il necessario corollario che non c’è potere che non si esprima attraverso un sapere.
Per liberare il sapere dal potere Kant (Heidegger, Fenomenologia) distingue fra l’autocoscienza pura e l’autocoscienza empirica, ovvero, tra l’io dell’appercezione e l’io dell’apprensione. Apprensione significa percezione, esperienza del sussistente, esperienza cioè dei processi psichici compiuta grazie al cosiddetto senso interno. L’io puro, l’io dell’autocoscienza, dell’appercezione trascendentale, non è un fatto empirico, ma in ogni esperienza empirica, intesa come Io faccio esperienza, c’è sempre già coscienza di questo io quale fondamento ontologico della possibilità di ogni esperienza. L’io empirico in quanto anima può venire pensato in maniera teorica, come idea, e allora coincide col concetto di anima, dove anima è intesa come fondamento di ciò che è animato o, come dice Kant, dell’animalità, del vivente in generale. L’io, in quanto pesonalitas trascendentalis è sempre e soltanto soggetto, è l’io-soggetto. L’io in quanto personalitas psychologica è sempre e soltanto oggetto, sussiste davanti a noi, è l’io-oggetto o, come dice direttamente Kant: Questo io-oggetto, l’io empirico, è una cosa. Ogni psicologia è pertanto scienza positiva del sussistente.
Da questo io psicologico, dice Heidegger, Kant distingue l’io dell’appercezione, l’io logico. Che l’io sia logico non significa per Kant, che esso sia pensato in maniera logica, ma vuol dire che l’io è io in quanto “io congiungo”, che sta alla base di ogni pensiero. Una tale egoità è la stessa per tutti i soggetti fattuali. Ciò non può significare che l’io logico è qualcosa di universale, di anonimo, ma esso è anzi, per sua essenza, proprio sempre il mio io. Caratteristica dell’egoità è che l’io è sempre mio. Quando dico Io penso, o Io mi penso, il primo io non è qualcosa di diverso, come sarebbe se in esso parlasse un io universale, irreale, ma si identifica con lo stesso io pensato o, come dice Kant, con l’io che può essere determinato. L’io dell’appercezione si identifica con l’io che può essere determinato, con l’io dell’apprensione, soltanto che non è necessario pensare, insieme al concetto dell’io determinante, quel che io sono in quanto io empirico, determinato. L’io determinante dell’appercezione è. Kant afferma che di questo ente e del suo essere non possiamo dire altro fuorché che esso è. Solo perché l’io, in quanto questo io stesso, è, esso può scoprirsi come empirico.
Che l’io della appercezione trascendentale sia un io logico, vale a dire il soggetto “dell’io congiungo”, non vuol dire né che esso sia diverso dall’io psichico, sussistente ed effettivo, e neppure che non è affatto qualcosa di essente. Significa invece soltanto che l’essere di quest’io risulta problematico, per Kant in generale indeterminabile, e che in ogni caso non può essere affatto determinato con gli strumenti della psicologia. La personalitas psychologica presuppone la personalitas trascendentalis.
È proprio contro la tirannia di questa personalitas trascendentalis che si abbatte l’ira di Stirner. Di fronte alla personalità trascendentale non resta altro che la cosa in sé. Questa cosa in sé siamo noi, e di noi la filosofia critica non può dire nulla, se non mostrare la via del suo dover essere, del suo conformarsi alla sua legge, alla sua verità.
Nella filosofia critica, dice Hegel (Enciclopedia §41) l’oggettività vien detta l’elemento di universalità e necessità, cioè delle determinazioni stesse del pensiero, – il cosiddetto a priori. Ma la filosofia critica allarga l’antitesi in modo che nella soggettività rientra la totalità dell’esperienza, cioè entrambi quegli elementi [materia per sé isolata e infinitamente varia; – l’altro, la forma, i caratteri dell’universalità e della necessità], e di fronte a questi non resta altro che la cosa in sé.
L’unità del molteplice, dice Hegel (§42), è unità trascendentale dell’autocoscienza: identità originaria dell’io nel pensiero. Le rappresentazioni date dal sentimento e dall’intuizione sono un molteplice. Questo molteplice della sensazione e dell’intuizione, essendo dall’io riferito a se stesso e riunito in sé come in una coscienza (appercezione pura), viene ridotto così a identità, a una connessione originaria. I modi determinati di questo riferimento sono i puri concetti dell’intelletto, le categorie.
L’io, l’unità dell’autocoscienza, è del tutto astratto e pienamente indeterminato: come si può dunque giungere alle determinazioni dell’io, alle categorie? Per buona fortuna si trovano già nella logica comune, empiricamente indicate, le diverse forme del giudizio.
Giudicare è pensare un determinato oggetto. I diversi modi del giudizio, già belli e pronti e annoverati, porgono dunque le diverse determinazioni del pensiero.
La ragione, dice Hegel (§45), è la facoltà dell’incondizionato. L’incondizionato è l’infinito, ciò che è uguale a se stesso, identità originario dell’io o pensiero. Ragione si chiama questo astratto io o pensiero, il quale prende a oggetto o scopo la pura identità. Identità priva di determinazioni alla quale le conoscenze di esperienza sono inadeguate, poiché sono determinate. E quando si assume siffatto incondizionato come l’assoluto e il vero della ragione (come l’idea), le conoscenze dell’esperienza sono dichiarate come il non vero, come apparenze.
Conoscere, dice Hegel (§46), non significa altro che sapere un oggetto secondo il suo contenuto determinato. Ma il contenuto determinato contiene una molteplice connessione in se stesso e ha connessioni con molti altri oggetti. Per la determinazione di quell’infinito o della cosa in sé, la ragione non avrebbe altro che le categorie; ma, allorché le vuole adoperare a tale scopo, essa diviene trascendente.
La realtà effettiva, l’aldiqua, l’immediato, si presenta, dice Hegel (§50) come un’accolta d’infinite accidentalità, o come un’accolta di infiniti fini e relazioni di fini – Pensare quest’essere pieno significa cancellare da esso la forma delle individualità e accidentalità, e concepirlo come un essere universale, in sé e per sé necessario – come Dio.
Poiché, dice Hegel, le percezioni e l’aggregato di esse, il mondo, non mostrano, in sé come tali, l’universalità, alla quale viene sollevato dal pensiero, questa universalità non viene giustificata dalla rappresentazione empirica del mondo.
L’elevazione del pensiero sul sensibile, il suo passare aldilà del finito verso l’infinito, il salto che viene fatto, col rompere le serie del sensibile, nel soprasensibile, tutto ciò è il pensiero stesso; questo trapasso, dice Hegel, è soltanto pensiero. Dire che questo trapasso non debba essere fatto, è dire che non si debba pensare. In effetti, dice, gli animali non lo fanno: se ne restano fermi all’apprensione sensibile o all’intuizione: e perciò non hanno alcuna religione.
In questo atteggiamento bruto la relazione del punto di partenza col punto finale viene rappresentata così come solamente affermativa, come un inferire da uno, che è e resta, ad un altro, che ugualmente è. Ma per questa via è impossibile pensare il mondo. Si salta di sensazione in sensazione, di percezione in percezione, di fatto in fatto, senza tregua, con in mano un pugno di mezze verità, di narrazioni, di punti di vista e panzane tutte ugualmente legittime – un appiattimento sulle stronzate.
6
La verità ti rende libero, non prima di averti ucciso.
L’anelito verso la libertà, intesa come sovranità, ci ha tolto la nostra individualità propria, creando il rinnegamento di sé. Ed ecco, dice Stirner, che quanto più divento libero, tanto più mi sovrastano costrizioni di fronte alle quali mi sento sempre più impotente. Il figlio delle selve, che non è libero, non percepisce ancora affatto tutte le barriere che opprimono l’uomo civilizzato: egli si sente più libero di quanto non si senta quest’ultimo.
Se libero vuol dire conquistare l’indipendenza da ogni vincolo esterno, allora voler essere libero equivale a volersi morto. Meglio soffrire, dice Stirner.
Il fatto che io soffro e tremo, dice, dimostra che sono ancora in me, ancora padrone di me: io resto mio. La mia gamba non è «libera» dalle percosse del padrone, ma è la mia gamba, da me inseparabile. Il padrone provi un po’ a strapparmela e poi guardi se quel che ha in mano è ancora la mia gamba! Quel che tiene in mano non è altro che il cadavere della mia gamba, che è tanto poco la mia gamba quanto un cane morto è ancora un cane.
La verità è necessità e universalità, l’egoismo è determinazione e unicità. La verità è morte, l’egoismo è vita. Se c’è vita, c’è egoismo. Dunque c’è egoismo anche nella ragione e nella religione. Non potrebbe essere altrimenti. Ecco ribaltato il quadretto kantiano.
L’uomo (vivo), l’individuo, l’unico, è vivo, dunque è avido. Non fa niente a gratis. Dunque, chiede Stirner, quel suo «fare il bene per amore del bene» che prospettiva di ricompensa riserva? Quale soddisfazione prospetta? Perché una soddisfazione dev’esserci, visto che il vivo non fa niente per niente. Anche la religione, dice, è fondata sul nostro egoismo, e lo sfrutta. Calcolata sulla base dei nostri desideri, essa ne soffoca molti a vantaggio di uno solo, per esempio quello della beatitudine.
La religione, dice Stirner, mi promette il «sommo bene» e per raggiungerlo io non presto più attenzione a nessun altro dei miei desideri, che restano, cosi, insoddisfatti. Presto solo attenzione al desiderio di salvezza, di beatitudine eterna. Tutto quel che viene fatto per raggiungere questo obiettivo, obiettivo egoistico, perché parte da me e vuole soddisfare me, viene nascosto, ammantato dal suo contrario.
Tutto ciò dimostra un egoismo inconfessato, segreto, mascherato e nascosto. Ma siccome si tratta di un egoismo che non volete confessare neppure a voi stessi, che nascondete a voi stessi, insomma di un egoismo non aperto o manifesto, ma inconsapevole, non è in fondo egoismo, ma schiavitù, servitù, rinnegamento di sé. Voi siete egoisti e non lo siete, perché rinnegate l’egoismo. Quando sembra che lo siate più decisamente, ecco che subito dichiarate ripugnanza e disprezzo per la parola «egoista».
Al fondo della religione dell’amore e del comportamento disinteressato si trova l’egoismo. Al fondo della ragione e del diritto si trova l’egoismo. Io decido se io sono nel giusto – dice Stirner. Fuori di me non c’è alcun diritto o giustizia. Se qualcosa è la cosa giusta, la cosa che ci vuole per me, allora è giusta. È possibile che non per questo essa sia la cosa giusta per gli altri: questo è affar loro, non mio: si difendano, se vogliono! E anche se a tutto il mondo non andasse bene, ma per me fosse la cosa giusta, cioè se io la volessi, io non chiederei l’opinione o il pensiero del mondo intero. Così fanno quelli che sanno apprezzare se stessi, ciascuno nella misura in cui è egoista: la forza, infatti, precede il diritto e invero – a pieno diritto!
Questa forza che mi dà il diritto non è una forza che si possa giustificare con la natura, col diritto naturale – per esempio il diritto di nascita. La natura, dice Stirner, non può autorizzarmi o qualificarmi a fare (cioè mettermi nelle condizioni reali di poter fare) ciò che solo la mia azione mi autorizza a osare. Che sia la natura o Dio o la decisione popolare, ecc., a concedermi un diritto, si tratta sempre di un diritto estraneo, di un diritto che non sono io a concedermi o a prendermi.
La forza non promana da un punto di origine (Dio, Natura, Popolo, eccetera) – Forza è un concetto della ragione.
L’individuo, dice Stirner, non ha una vocazione, bensì forze che si esprimono là dove sono, perché il loro modo di essere consiste unicamente nel loro esternarsi, ed esse non possono mai restare inoperose, così come la vita stessa che, se si «fermasse» anche solo un secondo – ma è mai possibile che la vita si fermi? -, non sarebbe più vita.
Allora, dice Stirner, si potrebbe esclamare all’uomo: usa la tua forza! Ma questo imperativo verrebbe interpretato come se fosse compito dell’uomo far uso della sua forza. Non è così. Ciascuno utilizza, piuttosto, realmente e in ogni istante, tanta forza quanta ne possiede.
Si sente dire talvolta di un vinto che egli avrebbe dovuto tendere di più le sue forze, ma si dimentica che se quando stava per soccombere avesse avuto la forza di tendere le sue forze (per esempio le sue forze vitali), l’avrebbe fatto di sicuro: quello scoraggiamento momentaneo era appunto – impotenza, sia pur di un solo minuto.
È certo possibile acuire e moltiplicare le forze, dice Stirner, specialmente attraverso la resistenza nemica o l’assistenza amica, ma, quando non vengono adoperate, si può esser certi che esse non ci sono neppure. Si può sprigionare il fuoco da una pietra, ma senza un forte attrito non è possibile; allo stesso modo anche un uomo ha bisogno di una «spinta».
Proprio per questo, dice Stirner, cioè per il fatto che le forze sono già di per sé sempre attive, l’ordine di adoperarle sarebbe superfluo e senza senso.
Adoperare le proprie forze non è la missione e il compito dell’uomo, ma è la sua azione sempre reale e presente. «Forza», precisa Stirner, è soltanto una parola più semplice per indicare la manifestazione della forza.
Non c’è «La forza» che l’individuo si incarica di attivare. La forza non è nell’individuo, l’individuo non è origine della forza. Affinché la forza si sprigioni c’è bisogno di un attrito. Sfregando due pietre vediamo sprigionarsi qualcosa, e chiamiamo questo qualcosa forza del fuoco – ci sbagliamo. Non c’è alcuna forza nel fuoco o del fuoco. Il fuoco non è una proprietà della forza. La forza è il differenziale tra le due pietre, oppure sarebbe più corretto dire che le due pietre si differenziano nella forzatura reciproca – si intuisce qui tutta la difficoltà di una descrizione anti-teleologica della forza; sarebbe corretto dire che all’inizio – ma anche qui parlare di inizio è improprio, perché nella forzatura si tratta di un circolo di rimandi che crea i proprio presupposti – all’inizio ci sono le pietre che si sfregano. Senza la forzatura non ci sarebbe alcuna scintilla, dunque alcuna forza e alcun potere del fuoco.
Che cos’è dunque questa forzatura se non è pietra, se non è forza, se non è rapporto di una pietra con l’altra?
Qui ad essere inadeguate non sono le risposte, ma è la domanda, è il «che cosa». Questo «che cosa» – qui arriviamo al cuore dell’argomento di Stirner – è esso stesso un effetto della forzatura.
La forza è una fissazione, prodotta da uno spettro. La forza è al di sopra di me, è assoluta ed esiste solo in un essere superiore, dal quale mi viene concessa come una grazia: La forza è del sovrano. La potenza, invece, esiste solo in me, il forte, il potente.
Il diritto, dice Stirner, è ridotto a nulla se viene inghiottito dalla forza del potere sovrano. Si abbatte come una mannaia tagliando allo stesso modo tutte le teste – indifferentemente. Abroga la mia possanza e il mio egoismo, per restituirmi un potere che subito riassorbe, come potere delegato. Detentore legittimo della forza, interprete autorizzato del mio egoismo, ogni sovrano opera una traduzione della mia possanza – e ogni traduzione è un tradimento.
La tigre che mi assale ha i suoi diritti e io che l’uccido ho i miei. Ma contro di lei non difendo i miei diritti, bensì me stesso. Non c’è nessun diritto che io possa far valere contro la tigre. Solo la possanza può decidere della vita e della morte. Il diritto, se ce n’è, si gioca in questo duello tra possanze.
Poiché la ragione opera attraverso traduzioni e mediazioni ci si aspetterebbe da Stirner un rifiuto della traduzione e del sapere e, di contro, l’esaltazione di uno stato ferino, dove il più forte si riversa sul più debole, e dove tutto ricomincia sempre daccapo, senza cognizione di ciò che è stato, di ciò che si è diventati, senza memoria, senza ricognizione del terreno di battaglia, senza strategia, senza pensamenti e ripensamenti.
Il rifiuto della traduzione non si risolve per Stirner in rifiuto della ragione. Stirner inverte il rapporto tra sapere e potere. Chi ha il potere ha ragione: se non avete il primo, dice, non avete nemmeno la seconda. La ragione del più forte è sempre la migliore. Non c’è da discutere. Se la tigre abbatte l’uomo, è la tigre ad avere avuto ragione dell’uomo. Non si danno parametri esterni alla dinamica delle forze – nessun aldilà, nessuna trascendenza.
Eppure la trascendenza è resuscitata e asservita al gioco delle possanze. Mi faccio forte anche della ragione.
Un secolo dopo Heidegger ha gioco facile nello smontare questo teatrino metafisico.
7
Stirner subordina il sapere al potere. Ma il sapere non si lascia addomesticare facilmente.
L’idea di diritto, l’idea di bello, l’idea di vero, dice Stirner, è originariamente idea mia, ossia ha la sua origine in me. Ma da me, che ero la sua origine, si è distaccata, si è manifestata come «parola» e cosi «si è fatta carne», è diventata un’idea fissa. Ormai non riesco più a sbarazzarmene: dovunque mi volga, eccola davanti a me! Cosi gli uomini, che crearono essi stessi l’idea del «diritto», non sanno più esserne padroni: la loro creatura li sopraffà. Ecco il diritto assoluto, cioè absolutum, distaccato da me. Nella misura in cui lo veneriamo come assoluto, non possiamo più consumarlo ed esso ci toglie la nostra forza creatrice; la creatura vale più del creatore: è «in sé e per sé».
L’uguaglianza dei diritti, il socialismo e il comunismo – la verità – sono appunto dei fantasmi.
Che cos’è un fantasma?
È un’idea che si è distaccata e si manifesta come parola. È una parola che si mostra, ma che non sta ferma nella sua immobilità di cosa, come invece dovrebbe stare quando è inscritta su un pezzo di carta. Essa invece si anima. Ci parla come un morto vivente, come un fantasma. Ha preso corpo, ma non il corpo possente del vivente, ma il corpo spaesante di un fantasma, di un un morto, di un morto che si comporta come un vivente – un sopravvivente.
Cosa fa questa parola, distaccata dal suo creatore (alienazione), e a esso contrapposta?
Lo vessa, lo domina, lo appiattisce. Agisce su di lui come un metro, come una moneta: lo misura e lo contabilizza, permette che sia paragonato, che diventi un tipo, un esemplare, un pezzo, un mezzo, un prodotto, un oggetto. Soggetto o sostanza diventa la parole, l’idea, il sovrasensibile. Il sensibile si presenta come spoglia in cui il sovrasensibile si manifesta.
Questa è la scena completamente hegeliana in cui Stirner inquadra il sapere.
La parola, dice Stirner, ci solleva dalla nostra unicità e ci permette di entrare in relazione e formare una comunità. Ma ciò rappresenta un declino, una debolezza, una caduta, una perdita per l’egoista.
La nostra debolezza, dice, non sta nel contrasto che ci oppone agli altri, bensì nel fatto che non siamo completamente, cioè totalmente, divisi da loro, ossia nel fatto che cerchiamo una «comunità», un «legame», nel fatto che ci facciamo un ideale della comunità.
La comunità ideale o l’ideale di comunità rappresenta, per l’unico, una sottomissione, una riduzione ad esemplare, una soggezione ad un pensiero unico, ad un grande racconto, un livellamento delle differenze, un appiattimento su un modello prefabbricato.
Meglio vivere il contrasto estremo e decisivo, fra l’unico e l’unico, il quale, in fondo, dice Stirner, è al di là di ciò che si chiama propriamente «contrasto», senza però ricadere per questo nell’unità e nell’unitarietà.
Come unico, dice, tu non hai più niente che ti accomuni all’altro e, quindi, neppure che ti separi da lui o ti renda suo nemico; tu non cerchi di aver ragione, e non stai più con lui sul terreno comunitario. Il contrasto scompare nell’esser perfettamente divisi gli uni dagli altri, cioè nell’unicità degli individui.
Questo isolamento, precisa Stirner, questa differenza, più profonda della differenza tra amico e nemico, potrebbe certo essere vista come un nuovo elemento comune o una nuova forma di eguaglianza. In quanto differenti saremmo tutti uguali. Ma qui, dice, l’eguaglianza consiste appunto nella disuguaglianza, anzi, non è altro che questo: un’uguale disuguaglianza, tale poi in realtà solo per chi istituisce confronti. Perché in verità non si dovrebbe parlare né di uguaglianza né di disuguaglianza. In verità – conclude Stirner – non si dovrebbe parlare affatto, si dovrebbe tacere. Lasciare le differenze al loro differimento implica rimanere in silenzio.
Più precisamente Stirner dice – ma qui il giro retorico va valutato con attenzione – dice, per concludere, che gli rimane da ritirare quella dubbia espressione di cui ha voluto far uso soltanto finché frugava nei visceri del diritto, così lasciando intatta almeno la parola. Ma di fatto, dice, col concetto, anche la parola perde il suo senso.
Ha usato la parola, ma adesso, alla fine, quando il discorso sta per volgere al termine, quando sta per arrivare alle sue ultime righe, con altre parole, usando parole, fino all’ultima parola – che è la parola fine – dice che la farà finita con le parole, che se si vuole conservare la differenza tra i differenti bisogna smetterla di parlare, in quanto ogni parola non fa altro che tirare in ballo l’identità.
Non si esce dalla parola se non con un’ultima parola. Strana torsione hegeliana per un discorso empirista dall’inizio alla fine. Eppure, Hegel, nell’Enciclopedia, aveva chiarito che la strada empirista, anche di un empirismo estremo, era un vicolo cieco.
L’illusione fondamentale nell’empirismo, dice Hegel (§38), consiste sempre nel far uso delle categorie metafisiche di materia e forza, di uno, molti, universale, anche d’infinito ecc., e con queste categorie andar sillogizzando, inconsapevole di praticare la metafisica, e adoperando quelle categorie e le loro connessioni in modo del tutto privo di critica e di consapevolezza.
Fin tanto che si rimane nella parola, si rimane nella metafisica.
In questo quadro, totalmente hegeliano, le alternative sono poche: 1) parlare, e tirarsi dietro tutta la metafisica; 2) tacere, non dire niente, vivere in una notte in cui tutte le vacche sono nere.
8
Stirner decostruisce la teleologia di Hegel. Eppure, ritenendo dato il salto dal sensibile al sovrasensibile non discute il tema dell’avvio, finendo per ripristinare un’idea di origine (creazionismo) ereditata dal romanticismo.
Nietzsche, sul quale Stirner ha avuto una grande influenza, e in alcuni frammenti quasi lo citi alla lettera, sviluppa una decostruzione completa dell’idea di origine, seppellendo il romanticismo ed Hegel. A questa decostruzione ha dato il nome di Eterno Ritorno. Senza questa decostruzione si rimane ostaggi di un pensiero debole – dunque di una delle sorgenti del post-modernismo.