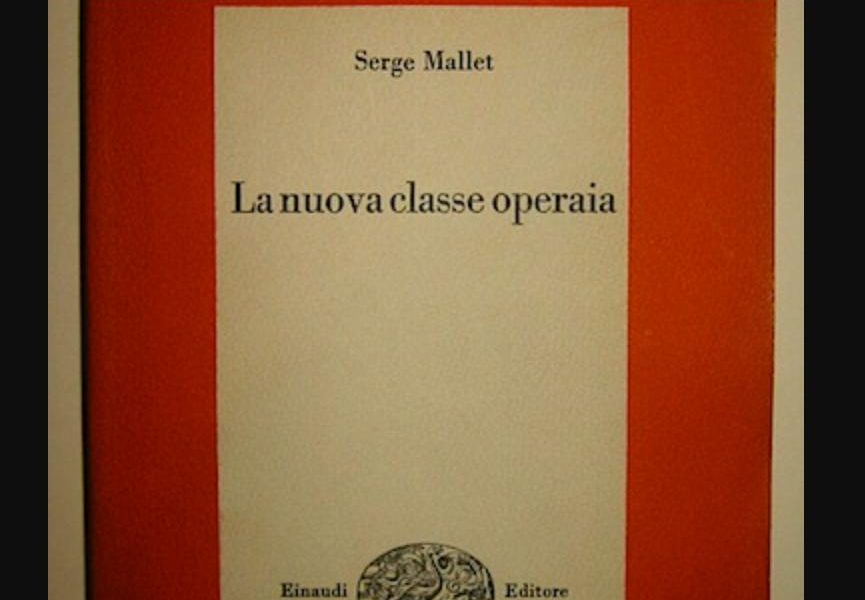I
«La nuova classe operaia» di Serge Mallet, pubblicato in Francia nel 1963, raccoglie alcuni articoli scritti nella seconda metà degli anni Cinquanta e pubblicati sulla rivista di Sartre Les Temps Modernes. Si tratta di inchieste condotte in alcune aziende francesi al vertice dell’innovazione tecnologia e nelle quali emerge, appunto, una nuova classe operaia – nuova rispetto al modello descritto da Marx nel Capitale.
Tutta una serie di fattori, dice Mallet, hanno spinto il sistema verso un insieme di assestamenti tendenti a evitare quella «accumulazione della miseria a un polo» che era stata prevista dall’autore del Capitale. Oggi, dice, anche i teorici più dogmatici del movimento operaio sono pressappoco d’accordo nell’ammettere che non c’è stata o, più esattamente, che non c’è più, nei paesi capitalistici avanzati, una «pauperizzazione assoluta». E non c’è perché il capitalismo, volendo evitare problemi al sistema, ha sviato le rivendicazioni operaie dalla sfera della produzione a quella del consumo. Lo stesso sindacato comincia a disinteressarsi della produzione per accontentarsi di ottenere miglioramenti salariali utilizzabili nella sola sfera del consumo.
La svolta nelle relazioni sindacali, dice Mallet, è stata una conseguenza del mutamento delle condizioni tecniche della produzione capitalistica. Non bisogna imputare al sindacato, alla sua cosiddetta burocratizzazione, la migrazione dalla produzione al consumo.
Lo stesso Lenin, nel 1923, non riteneva che le condizioni tecniche di produzione, introdotte con la catena di montaggio e il taylorismo, potessero alterare, fino a trasformarla radicalmente, la condizione operaia. Addirittura, dice Mallet, Lenin vedeva nelle grandi unità industriali organizzate sulla base del lavoro a catena l’avvenire dell’industria e riteneva possibile conciliare questo modo di produzione disumanizzante con la piena realizzazione dell’uomo socialista.
Lo spostamento dalla produzione al consumo, accompagnato dalla produzione in serie, genera un nuovo atteggiamento rispetto all’oggetto d’uso quotidiano. Nasce il cosiddetto consumismo, ovvero l’idea di una emancipazione sociale legata a oggetti o servizi un tempo appannaggio di una classe borghese medio-alta. Automobili, frigoriferi, televisori, viaggi, vacanze, studio, sport, pensione, cinema, teatro, libri, alloggio decoroso, mobili, eccetera diventano elementi dello status symbol di una nuova e vasta classe sociale che non corrisponde più né alla classe degli operai specializzati, alla cosiddetta aristocrazia operaia, né alla classe dei garzoni di bottega.
La grande industria produce, insieme ai nuovi oggetti di consumo, anche i consumatori di questi oggetti, e non li produce soltanto in quanto meri destinatari di un reddito percepito sotto forma di salario, ma, con la pubblicità e le strategie di marketing, li produce offrendo modelli psico-sociali consumabili insieme ai prodotti stessi. Insieme al bene d’uso viene venduto anche un mondo di riferimento e un contesto di sfoggio, di opposizioni e di differenze che fanno funzionare il prodotto in serie come un prodotto esclusivo, eccetera.
A questa figura di consumatore corrisponde la figura di un produttore desertificato, deprivato di ogni qualità o specializzazione e al quale non è richiesto alcun sapere particolare, alcuna capacità artigianale, manuale o intellettuale.
La sociologia del lavoro americana, dice Mallet, ha da tempo osservato che la tecnica del training on job, della formazione sul campo, praticata così generalmente nelle fabbriche moderne, non può in alcun caso venire assimilata a una vera formazione professionale. Dopo due o tre giorni di formazione, i nuovi arrivati vengono immessi nella linea di produzione e in capo a una sessantina di giorni il loro rendimento può far concorrenza a quello dei più esperti tra i loro compagni. Contrariamente alle illusorie speranze che la maggior parte dei dirigenti sindacali – proveniente essa stessa dal vecchio strato degli operai professionali – continua a nutrire, col progresso della tecnologia la formazione professionale non è più indispensabile. La maggior parte degli specialisti degli uffici metodo la considerano addirittura dannosa che utile al rendimento produttivo.
Questa analisi di Mallet, in primo luogo, ha il merito di cercare le ragioni della trasformazione all’interno del capitalismo. Non si cerca, sbrigativamente, di spiegare i cambiamenti ricorrendo a ragioni esterne. Non è stato il socialismo reale a spingere verso il consumismo. È il conflitto interno tra capitale e lavoro che ha spinto il capitale verso il New Deal.
Non ci sono ragioni esterne, per esempio l’opposizione metropoli-periferia, che spieghino questo cambiamento. Nessun terzomondismo è in grado di spiegare la virata del capitalismo verso la piena occupazione.
In secondo luogo, questa analisi riporta al centro il tema della produzione. È nella produzione che si avvia un cambiamento che si ripercuote sull’intera società.
Non si tratta di riscoprire un determinismo positivista da seconda internazionale. Si tratta solo di registrare una simmetria tra i mutamenti nella struttura della fabbrica e i mutamenti nella mentalità o nella cosiddetta vita privata.
Tra la vita privata e la vita pubblica, tra la vita domestica e la vita di fabbrica, tra il consumo e la produzione c’è un canale in cui scorre una corrente. I due settori sono permeabili. La fabbrica permea la società e viceversa. Il consumo produce la produzione. Non solo gli fornisce il finish stroke – lo attualizza -; ma gli fornisce anche la premessa, la causa finale, la spinta (Trieb), la possibilità, la potenza, eccetera.
Sull’altro versante, la produzione produce il consumo fornendogli il materiale – causa materiale; determina il modo del consumo, genera nei consumatori il bisogno di quei prodotti che la produzione offre.
Si tratta di due punti che attraversano il discorso di Mallet in profondità e che lo caratterizzano in quanto Operaismo.
Il collegamento tra pubblico e privato diventa sempre più stringente. Ripeto, bisogna considerare questi due ambiti come disposti su un medesimo piano strutturale – nessuna gerarchia, nessuna precedenza, nessuna ultima istanza. Bisogna anche considerare che questa distinzione è una distinzione di comodo; e che in verità non c’è alcuna distinzione, che ciò che le riviste patinate come Elle, settimanale «femminile» della piccola e media borghesia, e la rivista Olimpo dell’élite cominciano a chiamare neo-capitalismo presentando Keynes come Brigitte Bardot; bisogna considerare che tutto ciò, ovvero il neo-capitalismo, con la sua produzione pienamente asservita alla vita privata, è una finzione, un momento della costruzione della produzione – la sua causa finale, appunto.
La progressiva estensione degli elementi sociali del salario (assegni familiari, indennità di affitto, pensioni, sicurezza sociale, sanità, istruzione, trasporti pubblici, etc.) diminuisce il significato di questa differenza. La vita quotidiana della classe operaia ha cessato, o sta per cessare di rappresentare un comportamento sociologico particolare. Tutti concordano nel dimostrare che, scrive Mallet, la classe operaia va perdendo progressivamente la maggior parte delle caratteristiche esteriori acquisite nel suo processo di formazione storica.
Questa indistinzione in cui è gettata l’intera società è dovuta in primo luogo alla produzione di massa o, in ogni caso, alla grandi strutture di massa. L’industriale non può costruirsi un ospedale tutto per sé, non può avere un’autostrada tutta sua. L’operaio e il padrone si curano nello stesso ospedale, viaggiano sulle stesse automobili, percorrono le stesse strade. Giovanni Agnelli, come diceva Andy Warhol, non può avere un coca-cola più buona di quella che beve il barbone ad un angolo di strada.
Nei centri balneari della Costa Azzurra, della Sicilia o della Grecia, scrive Mallet, giovani operai metallurgici abitano negli stessi bungalow «tahitiani» delle figlie dei direttori, comprano gli stessi dischi e danzano gli stessi ritmi. L’amalgama degli strati sociali nei nuovi complessi urbani in cui si trovano fianco a fianco operai qualificati, quadri, tecnici, salariati del settore terziario e liberi professionisti contribuisce ampiamente all’omologazione. La classe operaia ha effettivamente finito di vivere separata: il suo livello di vita e le sue aspirazioni l’hanno fatta uscire dal ghetto in cui era confinata all’inizio dell’industrializzazione.
II
L’Operaio Comune, scrive Mallet, è il proletario allo stato puro. Si arriva fino a strappargli la coscienza di partecipazione individuale all’attività sociale. Il lavoro spersonalizzato, astratto, non rappresenta neanche più quel fattore di inserimento nel mondo che è ancora per l’operaio professionale. Nell’operaio professionale la coscienza di classe è legata alla consapevolezza di essere sfruttato in quanto produttore di ricchezza. Per l’Operaio comune le cose vanno in tutt’altro modo. La coscienza di classe, dice Mallet, si basa sul senso dello sfruttamento, e questo viene avvertito come espressione di una disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. È la differenza nella distribuzione del reddito, ed è un conflitto intorno al reddito e al consumo che caratterizza la lotta dell’Operaio nel periodo del New Deal. La classe, dice Mallet, cessa di essere collegata direttamente all’attività produttiva per diventare espressione di una condizione sociale. Anche il temine stesso di Operaio, che denota chi è legato alla produzione, lascia il posto ad altri nomi, ad altre definizioni – il salario diventa reddito.
Questo smottamento, dice, è causato da molti fattori. La scarsa formazione richiesta e l’instabilità dell’impiego sfavoriscono la fabbrica quale luogo di aggregazione, spostando questa attività verso l’abitazione e il quartiere. Quello che l’Operaio Comune è incapace di ottenere in quanto produttore cerca di ottenerlo in quanto consumatore.
In questo cambiamento l’automazione ha un ruolo centrale. In Francia, negli anni 50-56, l’automazione si diffonde nel settore petrolifero e petrolchimico, nella chimica sintetica, nell’energia elettrica, nelle telecomunicazioni, si diffonde nel settore avanzato dell’auto (Renault), nelle Ferrovie e nelle miniere di carbone.
L’introduzione dell’automazione rende difficile distinguere tra funzioni di produzione e funzioni di controllo, dunque rende sempre più difficile distinguere tra lavoro produttivo e lavoro improduttivo. Persino la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale assume caratteri più sfumati. La stessa natura del lavoro cambia. L’automazione, dice Mallet, elimina l’uomo dallo stadio della produzione degli oggetti. Questi vengono prodotti da altri oggetti, che sono di per se stessi capaci di rettificarsi, di correggere le proprie imperfezioni, e cioè di prodursi.
In questo contesto all’uomo rimane solo la funzione di motore immobile, di demiurgo, di elemento creatore, ma esterno al mondo della produzione, al quale partecipa soltanto con il Fiat iniziale.
Le macchine, una volta avviate, funzionano automaticamente, rifanno eternamente la stessa operazione, sostituendo la mano e persino il cervello dell’uomo.
I procedimenti di feedback, scrive Mallet, l’autocorrezione degli errori, l’auto-regolazione delle operazioni, la sintesi di certi dati economici e delle operazioni di produzione propriamente dette, assicurati da computer, sono oggi entrati nel campo degli stessi fatti economici. In queste condizioni, dice, l’intervento dell’uomo è sempre più relegato a valle e a monte del processo produttivo – come inventore e sorvegliante. È nel campo della creazione intellettuale, dell’invenzione da una parte e del controllo dall’altra, che si situa il suo dominio.
L’automazione trasforma sia la prestazione dall’operaio, sia la struttura della retribuzione. L’automazione fa scomparire il lavoro individualmente misurabile, svuotando di contenuto la stessa retribuzione individuale. Il salario del singolo ormai non è più altro che la ripartizione di una massa salariale totale, calcolata non sulla prestazione singola, ma esclusivamente sulla valutazione del posto di lavoro cui l’operaio è assegnato. Questo non vuol dire dover rinunciare alla nozione di plusvalore così come è stata enunciata da Marx. Ma il plusvalore non è più prelevato individualmente sulla forza-lavoro ceduta dall’operaio, ma è prelevato globalmente sul complesso del collettivo dell’azienda, sull’operaio sociale. Cambia completamente l’elaborazione di tutte le rivendicazioni salariali. La vita dell’operaio si trova e essere, che lo voglia o no, effettivamente integrata alla vita della fabbrica.
III
Il cambiamento nella struttura della fabbrica, l’automazione, l’Operaio Comune, la decostruzione della prestazione singola, l’estrazione sociale del plusvalore eccetera, si realizzano solo in quanto lo Stato è chiamato a intervenire e a pianificare la produzione.
La grande novità nel capitalismo si chiama Stato-Piano o Capitalismo di Stato pianificato.
Lo Stato deve intervenire come strumento regolatore e come principale finanziatore. Deriva da qui, dice Mallet, l’introduzione di tutti i meccanismi di pianificazione che si sviluppano in tutti i paesi capitalisti. È ben noto, dice, che l’espansione industriale francese è stata possibile solo grazie alla assunzione da parte dello Stato dell’infrastruttura industriale (energia, trasporti, ecc.) e per il suo intervento finanziario diretto e indiretto (in partecipazione con la nazionalizzazione degli istituti di credito e la tecnica dei prestiti garantiti).
Anche nel campo del consumo, che è forzato e orientato, lo Stato è portato a intervenire come protettore dell’industria: le enormi spese per la costruzione e manutenzione delle strade, ad esempio, sono indispensabili alla sopravvivenza dell’industria automobilistica.
Ma la funzione più importante che lo Stato svolge o, perlomeno, garantisce, funzione che Mallet si limita ad accennare, è la deterritorializzazione del patriarcato, delle cure parentali, della reciproca assistenza, della formazione, della cura dei bambini e degli anziani, eccetera. Senza questa virtualizzazione del patriarcato non sarebbero potuti apparire sul teatro della storia né la figura del consumista, né, tanto meno, la figura dell’operaio comune e dell’operaista.
IV
Anche il sindacato tradizionale si trasforma. Il ruolo degli iscritti, rispetto ai votanti alle assemblee, si riduce a un 9-10%. Questi iscritti, dice Mallet, non partecipano affatto alla vita sindacale, ristretta a un attivo militante sempre più ridotto. Il sindacato diventa una struttura esterna al mondo del lavoro. Si impone da fuori, attraverso la sua stessa potenza di rappresentanza, che cerca di imporre come rappresentanza ufficiale. Più che promotrice dello sciopero diventa l’istanza giuridica attraverso la quale lo sciopero si legalizza.
Accanto al sindacalismo tradizionale, e proprio sulla spinta dello Stato-Pianificatore e del dell’Operaismo sociale, si sviluppa un nuovo protagonismo operaio. Assistiamo, dice Mallet, a fianco del fronte politico tradizionale retto dai partiti e dal fronte sociale retto dai sindacati, all’apertura di un terzo fronte nella lotta secolare tra capitale e lavoro: il fronte economico, attraverso cui il movimento operaio si oppone al sistema capitalista non sulla base di opzioni ideologiche o di rivendicazioni sociali, ma sulla constatazione pratica dell’importanza di questo sistema ad assicurare lo sviluppo continuato e armonioso delle forze produttive. La divisione tradizionale tra il movimento sindacale e il movimento politico della classe operaia viene ad essere rimessa in causa, dice Mallet, i sindacati si vedono costretti come organismi economici a politicizzarsi nel vero senso del termine, e cioè non a fare monotonamente da eco alle parole d’ordine elettorali di questo o quel partito politico, ma a intervenire attivamente, con i mezzi e le forme d’azione che sono loro propri, nella vita politica del paese.
Certi, dice Mallet, si indignano oggi della pretesa dei sindacati a erigersi come forza politica autonoma e non vedono in quest’evoluzione che un rilancio dell’anarco-sindacalismo o dell’azione diretta di tipo operaistico. Per altri si tratta di una sordida manovra che tende a togliere al partito della classe operaia la direzione del movimento operaio. Gli uni e gli altri, dice Mallet, apologisti della società dei consumi o del giacobinismo, dimostrano semplicemente la loro incapacità a comprendere che, come era previsto da Marx, lo sviluppo della società moderna integra totalmente i processi politici e economici. Per un’organizzazione sindacale seria, dice, è impossibile non intervenire direttamente come forza sindacale nel campo politico, nella misura stessa in ci essa vuol sostenere il suo ruolo di forza sindacale.
L’automazione toglie all’Operaio Comune il potere che deteneva l’Operaio Specializzato, così come gli toglie il potere che convogliava nei sindacati tradizionali.
L’adattamento sempre più perfetto dell’Operaio al meccanismo tecnico-economico cui è integrato lo porta a superare nella sua azione rivendicativa la semplice lotta per la bistecca e a porre i problemi del ruolo degli operai nel funzionamento del meccanismo stesso. Le stesse condizioni del suo lavoro rafforzano il senso della sua responsabilità individuale di produttore.
Lo sciopero, dice Mallet, assume un carattere di violenza rivoluzionaria che arriva spesso fino alla distruzione e al saccheggio. Più che un atto politico, è un atto di affermazione. Col suo rifiuto, l’operaio si fa riconoscere come uomo; bloccando le macchine che, durante tutta la vita regolano i suoi movimenti, dà e si dà l’illusione di esserne ancora il demiurgo. Lo sciopero è la negazione dialettica della disumanizzazione del lavoro.
V
L’automazione cambia la cosiddetta «composizione organica» del capitale. È ciò che Mallet riscontra nella sua inchiesta alla Bull, l’azienda francese leader europea, negli anni Cinquanta, dell’industria elettronica.
La diminuzione relativa della massa dei salari pagata dalla Bull, scrive Mallet, non significa che questo: quando il potenziale di produzione si accresce, come la massa dei prodotti fabbricati, il costo dei salari resta costante, e questo perché l’aumento della produttività, in fin dei conti, non è più determinato dal rendimento personale dell’operaio, ma dalla macchina cui quello è addetto.
Quando nell’industria automatica la massa dei prodotti cresce, quando cresce il numero dei pezzi prodotti – in questi termini fisici Mallet misura la produttività – ciò non avviene per un accrescimento del rendimento dell’operaio. Tradotto in termini contabili ciò vuol dire che il volume del capitale costante cresce mentre quello del capitale variabile rimane fermo. Messi da parte i problemi di unità di misura e di misurazione, problemi giganteschi che Mallet salta a piè pari, ciò a cui si allude è l’idea che la fabbrica possa, al limite, funzionare, ovvero produrre, senza produttori – il che pone dei problemi evidenti al tema marxista dello sfruttamento.
Rimane il fatto incontestabile che l’automazione riduce la massa degli operai impiegati – crea disoccupazione. Che questa riduzione, di diritto, sia da mettere in connessione con la produttività e, addirittura, con un aumento della produttività, è quanto meno discutibile.
In ogni caso, scrive Mallet, si può dire che il vero problema della produttività, così come lo vedono i dirigenti delle aziende moderne, non è tanto quello dell’accelerazione del rendimento quanto quello della regolarità del rendimento. E ciò in quanto un volume sempre più piccolo di capitale variabile tiene vivo un volume sempre più grande di capitale costante, il quale, nel momento in cui non venisse tenuto in vita dal lavoro, produrrebbe perdite non giustificabili da politiche di fabbrica repressive. Insomma, una fabbrica altamente automatizzata tollera meno uno sciopero che un aumento dei salari.
VI
In queste inchieste operaie di Mallet si trovano tutti i temi che saranno ripresi negli anni Sessanta dall’Operaismo italiano. C’è il tema delle macchine e dell’automazione, c’è il tema dell’operaio sociale, c’è il tema del potere operaio e dell’autonomia operaia rispetto ai partiti politici e ai sindacati tradizionali. Soprattutto, c’è il tema della produzione, dell’operaio in quanto demiurgo, letto nell’ottica dell’umanismo sartriano, costruito a partire dall’interpretazione esistenzialista che di Hegel aveva dato Alexandre Kojève nelle sue lezioni degli anni Trenta.
Nessun effetto aveva ancora avuto la «Lettera sull’umanismo» di Heidegger. E il suo «Nietzsche» doveva aspettare ancora qualche anno per uscire in volume.
La critica al concetto di produzione non era stata minimamente recepita.
Quell’onda lunga che, secondo Heidegger, da Aristotele arriva sino a Nietzsche (e Sartre), e che si affaccia in Occidente sotto le spoglie dell’io penso, della logica hegeliana o della volontà di volontà nietzschiana, può benissimo essere letta come una storia della produzione o del produttore, del demiurgo o del soggetto.
La critica di questa lunga storia non sarà recepita in Italia almeno fino a tutto il 1978, anno in cui Toni Negri pubblica «Il dominio e il sabotaggio» – e sino a tutto il 2009, anno in cui Tronti scrive «Noi operaisti», dove il vezzo punk, nicciano e umanista torna a emergere in modo prepotente.