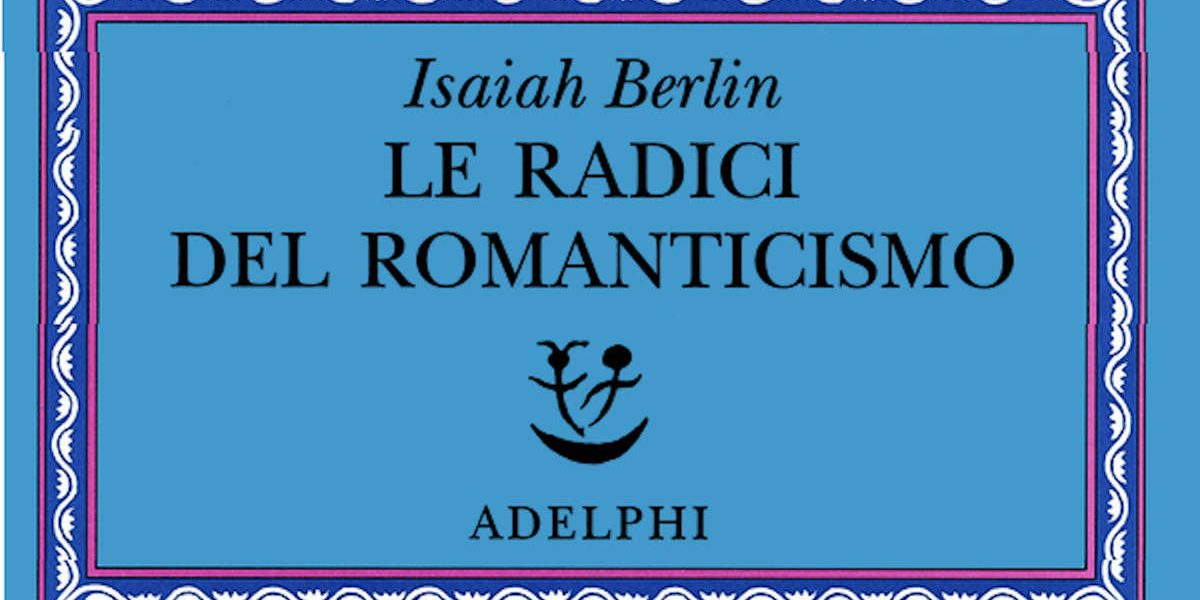La nostalgia e la paranoia, dice Isaiah Berlin (Le radici del Romanticismo), sono sentimenti tipici del Romantico, legati entrambi all’idea di infinito.
Per i romantici il mondo non si esaurisce nelle leggi che lo descrivono, come credevano gli illuministi. Esso è in perenne divenire. Azioni singole si legano e danno origine a nuove azioni, in un fluire inarrestabile. Arrestare questo movimento in una immagine, o fissarlo in una legge, è impossibile. Tutto costantemente muta, niente è mai stabile, niente è fissato nella pietra. Se il fluire delle cose mondane è come un’onda che non si posa mai, come potremmo anche solo tentare di descriverlo? Il ritorno o il congiungimento con una fissità originaria, pensata o descritta da leggi, è impossibile. La nostalgia è strutturale alla finitudine.
La nostalgia è dovuta al fatto che, siccome l’infinito non può essere esaurito, e siccome d’altro canto noi aspiriamo ad abbracciarlo, e l’aspirazione nasce dall’idea di completare la nostra finitudine, di avere risposte, nulla di ciò che facciamo potrà mai soddisfarci.
Bisogna subito chiarire che mentre il finito riserva in sé altre possibilità, può diventare qualcosa di diverso da ciò che è, l’infinito è perfetto, è completo, non necessità più di niente. Il finito è limitato da altri enti finiti, l’infinito non ha altro fuori di sé. Se avesse qualcosa fuori di sé, non sarebbe infinito. Pertanto, si può anche dire che l’infinito è assoluto, o sovrano, o libero. Libero è ciò che non ha fuori di sé alcun impedimento.
La nostalgia dell’infinito è la nostalgia di una libertà perduta, è il ricordo di essere caduti e diventati un ammasso mortale di ossa e muscoli.
Quando a Novalis fu chiesto quale pensava fosse la sua meta, quale fosse il senso della sua arte, disse: « Io sto sempre andando a casa, sempre alla casa di mio padre».
Anche la paranoia si abbevera alla stessa fonte. Il movimento è interminabile, le azioni si susseguono in numero indefinito, in un sistema complesso di cui l’ente finito è solo un brandello, un frammento incastrato tra altri frammenti.
Dall’idea di questo infinito movimento deriva un indirizzo ottimista, che vede nel superamento degli ostacoli un avvicinamento alla perfezione, un innalzarsi ad altezze sempre maggiori, verso quell’infinito rotondo dove tutto si quieta e ogni appetito si appaga, e un indirizzo pessimista, che vede nella catena delle cause e delle conseguenze, catena che non si arresta né percorrendola verso il passato, né percorrendola verso il futuro, il motivo di un universo non addomesticabile, non controllabile da un ente finito, ente che si trova pertanto sempre ad assere rintuzzato e diretto da potenze che si sottraggono, che si nascondo in una sorta di deep space (o deep web, come si dice oggi), del quale, chi vive sotto il sole, non è a conoscenza e non può dominare.
Per i romantici della fine del Settecento, dice Berlin, c’è dietro qualcosa, c’è qualcosa nelle buie profondità dell’inconscio, o della storia; c’è comunque qualcosa che noi non afferriamo, e che frustra le nostre aspirazioni più care. C’è una cospirazione nella storia. Dietro ogni cosa c’è sempre qualcuno: forse i gesuiti, forse gli ebrei, forse i massoni. In un modo o nell’altro, dice, tutti i nostri sforzi finiscono in nulla; deve quindi esserci una qualche formidabile forza ostile che ci aspetta al varco, e ci fa inciampare proprio quando pensiamo di essere sul punto di cogliere un grande successo.
La nostalgia e la paranoia si consolidano sulla base di una reazione violenta all’illuminismo, alla scienza, alla legge, alle verità eterne. Per un romantico come Wordsworth, dice Berlin, analizzare è assassinare.
II
L’interesse dei fratelli Schlegel, di Tieck, di Coleridge o Byron non andava alla conoscenza, o al progresso della scienza. Ai romantici non importava adattarsi alla vita, trovare un posto nella società, vivere in pace con il loro governo. Il senso comune e la moderazione erano lontanissimi dai loro pensieri. Essi, dice Berlin, credevano nella necessità di battersi fino all’ultimo respiro per le proprie convinzioni. Credevano nel valore della lotta fino all’ultimo sangue, indipendentemente da ciò per cui la si affrontava. Credevano che le minoranze fossero più sante delle maggioranze, che il fallimento fosse più nobile del successo, il quale aveva qualcosa di meschino, qualcosa di basso. Non erano disposti a vendersi, ma erano pronti a salire sul rogo per qualcosa in cui credere, per la sola ragione che ci si crede. Tale atteggiamento, dice Berlin, era relativamente nuovo. Ciò che essi ammiravano era la dedizione incondizionata, la sincerità, la purezza dell’anima, la capacità e la disponibilità a dedicarsi al proprio ideale, qualunque esso fosse. La peggiore tra tutte le cose possibili era il compromesso. Il vero tradimento era il compromesso.
Il romanticismo tedesco, che diede l’impronta al romanticismo mondiale, emerse, dice Berlin, tra il 1760 e il 1830. Era formato da un gruppo di uomini straordinariamente inesperti del mondo. Erano poveri, erano timidi, erano immersi nei libri, erano molto goffi in società. Capitava facilmente che venissero umiliati, dovevano servire come precettori dei grandi, erano costantemente fatti oggetto di ingiurie e vessazioni. Erano confinati e costretti nel loro universo. Erano, dice, come il ramoscello incurvato di cui parla Schiller, che finisce sempre con lo scattare e colpire chi lo tiene piegato. Erano uomini, perlopiù figli di pastori, dipendenti pubblici e simili, che avevano ricevuto un’istruzione che gli dette certe ambizioni intellettuali ed emozionali, col risultato che, siccome in Prussia troppi posti erano occupati da persone nate in alto, e le distinzioni sociali venivano preservate nella maniera più rigorosa, erano nell’impossibilità di dare piena espressione alle loro ambizioni, e si sentivano perciò piuttosto frustrati.
Niente di tutto ciò si trovava negli illuministi, perlopiù provenienti dalla classe nobiliare.
II
Nel suo Maometto, Voltaire non mostra alcun interesse per il profeta. Il suo scopo vero è attaccare la Chiesa. Ciò nondimeno, dice Berlin, Maometto emerge come un mostro superstizioso, crudele e fanatico, che schiaccia tutti gli sforzi miranti alla libertà, alla giustizia e alla ragione, e dev’essere dunque denunciato come un nemico di tutto ciò che per Voltaire conta di più: la tolleranza, la giustizia, la verità, la civiltà.
Al contrario, dice Berlin, Carlyle ammira Maometto, e lo ammira perché è una forza elementare, perché vive una vita intensa, perché ha molti seguaci; perché incarna qualcosa di elementare, un fenomeno formidabile, un grande e commovente episodio nella vita dell’umanità. Se ciò in cui Maometto credeva fosse vero o falso sarebbe parso a Carlyle totalmente irrilevante.
Nel Misantropo di Molière, dice Berlin, Alceste è un uomo amaramente deluso dal mondo, che non può conformarsi, non può adattarsi ai suoi falsi, volgari e repellenti valori. Ma non è lui l’eroe. Ci sono nella commedia persone più assennate che cercano di farlo rinsavire, e alla fine ci riescono. Alceste non è né detestabile né spregevole, ma non è lui l’eroe.
Nel 1780, questo tipo di personaggio, dice Berlin, non è più vagamente ridicolo. È diventato satanico, ed è questo il cambiamento, è qui la grande frattura tra la tradizione razionalistica o illuminata, ovvero la tradizione secondo la quale esiste una natura delle cose che bisogna studiare, che bisogna capire, che bisogna conoscere, e cui gli uomini debbono adattarsi se non vogliono correre il rischio di autodistruggersi o di rendersi ridicoli; è qui la frattura tra questa tradizione e la tradizione romantica, secondo la quale, al contrario, l’uomo semplicemente abbraccia i valori che abbraccia, e se occorre muore eroicamente per difenderli. In altre parole, dice Berlin, sembra emergere qui la nozione di martirio, di eroismo come una qualità da venerare in se stessa.
Nei Masnadieri di Schiller (1780-1790) dice Berlin, Karl Moor è un uomo che ha subito un torto, e che perciò diventa il capo di una banda di predoni, uccide e saccheggia e incendia, finendo con il consegnarsi ai gendarmi e farsi giustiziare.
Karl Moor, dice Berlin, è un eroe perfido e sleale, è un uomo che compie le sue vendette su una società detestabile, diventando un bandito e perpetrando una serie di atroci assassinii. Per tutto ciò, dice Berlin, alla fine viene punito, ma se ci domandiamo, Dove sta la colpa? Sta nell’ambiente d’origine di Moor? I suoi valori sono forse totalmente corrotti, o totalmente folli? Quale delle due parti ha ragione? Se ci chiediamo ciò, dice, si scopre che la tragedia non fornisce alcuna risposta. Di più, dice Berlin. La domanda stessa sarebbe parsa a Schiller sciocca e ottusa.
Schiller, dice Berlin, immagina che in un remoto passato sia esistita un’età dell’oro, in cui la passione non era disgiunta dalla ragione, e la libertà non era disgiunta dalla necessità. Poi è accaduto qualcosa di terribile, forse per causa della divisione del lavoro o di altro. Per effetto di una frattura di tipo rousseauiane, dice Berlin, prese forma il sapere, e con esso i suoi risultati, i desideri ingovernabili, le gelosie, le invidie, l’uomo in lotta contro l’altro uomo, l’uomo in lotta contro se stesso, la frode, la miseria, l’alienazione.
Per Schiller si pone il problema di ritornare o ripristinare questo stato di innocenza. Ciò può accadere solo per mezzo dell’arte. Schiller, dice Berlin, parla dello Spieltrieb, dell’impulso ludico. Dice che gli esseri umani possono liberarsi in un solo modo: adottando l’atteggiamento di chi è impegnato in un gioco. L’unico modo di farlo è collocarsi nella posizione di chi immagina liberamente e liberamente inventa. Se siamo bambini che giocano, qualunque cosa facciamo è cosa nostra, qualunque cosa facciamo non ci coarta. Coloro che giocano, dice, inventano il loro gioco, e perciò obbediscono alle sue leggi con entusiasmo, con passione, con piacere, perché è un’opera d’arte che essi stessi hanno costruito. Se soltanto riuscissimo a far questo, dice Berlin, saremo salvi. Ciò introduce per la prima volta nella storia del pensiero umano, dice Berlin, l’idea che gli obiettivi non sono qualcosa da scoprire mediante strumenti scientifici, mediante la lettura di testi sacri, ascoltando esperti o persone autorevoli, ma qualcosa da inventare. La verità e la bellezza non sono trovate o scoperte, ma ma generate, generate al modo in cui l’arte viene generata.
Se la metafora del gioco ha assunto una così grande importanza negli autori successivi, se la performance e persino il performativo hanno dominato la scena anche in tempi recenti, adesso si capisce il perché.
Eravamo dei bambini che giocano al sole, non distinguevamo tra necessità e libertà, tra passione e ragione, ed era un’epoca felice e innocente. Ma quest’epoca è finita, l’innocenza se n’è andata. La vita non offre più queste cose. Ciò che ora ci viene offerto come descrizione dell’universo non è nulla di più che una tetra macina causale.
III
Non c’è più composizione. Qui sta la tragedia romantica. Il conflitto non è prodotto da errori di calcolo, o di ragionamento, o da valutazioni sbagliate, eccetera. Il conflitto e lo scontro sono dovuti a un’ineluttabile collidere di elementi che errano senza legge sulla terra, di valori che non possono essere conciliati. Ciò che conta è che l’uomo si dedichi a questi valori con tutto se stesso. Se lo fa, è un eroe adatto alla tragedia. Se non lo fa, è un becero borghese che non vale nulla.
La figura che domina l’Ottocento, dice Berlin, è Beethoven, rintanato nella sua soffitta. Beethoven è un uomo che sente, dice e fa quello che pensa. È povero, è ignorante, è rozzo. Le sue maniere sono cattive, sa assai poco, e forse non è un personaggio molto interessante. Ma non si è venduto. Se ne sta nella sua soffitta, e crea. Crea in armonia con la luce che è dentro di lui, e non c’è altro che un uomo debba fare. È questo che fa di un uomo un eroe.
È evidente, dice Berlin, che era accaduto qualcosa che aveva distolto in modo radicale la coscienza dalla nozione che esistono verità universali e universali canoni artistici.
Il modello precedente, dice Berlin, era Newton, il quale aveva trovato la fisica in uno stato di totale confusione, con numerose ipotesi tra loro discordanti, che poggiavano su un mucchio di errori del pensiero classico e scolastico. Con pochissime mosse magistrali, Newton era riuscito a ridurre quest’enorme caos a uno stato relativamente ordinato. Partendo da un pugno di limpide proposizioni fisico-matematiche, aveva saputo dedurre la posizione e la velocità di ogni singola particella dell’universo. Newton aveva rimesso il mondo in sesto e definito le linee guida entro cui dovevano rientrare il vero e il falso, il giusto e l’errato. Aveva posto solide fondamenta all’idea che gli uomini non sono differenti, che ciò che vale veramente deve valere universalmente, cioè per tutti gli uomini in tutte le epoche e in tutti i luoghi.
IV
Il rigore matematico della fisica di Newton, usato come base da Kant per il suo sistema, viene spazzato via dalla radicalità della storicità romantica.
Hamann, forse il primo dei romantici tedeschi, pensava che, dice Berlin, applicate alla società umana, le scienze condurrebbero a una sorta di spaventevole burocratizzazione. Era contro gli scienziati, i burocrati, coloro che mettono ordine nelle cose, i levigati reverendi luterani, i deisti. Era contro chiunque volesse riporre le cose in scatole, chiunque volesse assimilare una cosa a un’altra, o dimostrare, per esempio, che creare era in effetti la stessa cosa che riunire dati forniti dalla natura e riorganizzarli secondo certi piacevoli modelli o principi.
Per Hamann, dice Berlin, la creazione era un atto personale assolutamente ineffabile, indescrivibile, inanalizzabile, mediante il quale un essere umano imprime il suo segno sulla natura, mette le ali alla sua volontà, dice la sua parola, esprime ciò che è dentro di lui, e che non ammette ostacoli di sorta. Ne segue, dice Berlin, che l’intera dottrina dell’Illuminismo uccide ciò che negli esseri umani è vivo, offre solo un pallido surrogato delle energie creative dell’uomo e di tutto il ricco mondo dei sensi, senza il quale è impossibile per gli esseri umani vivere, mangiare, bere, essere allegri, incontrare altri esseri umani.
Il bersaglio di Hamann erano i razionalisti alla Mendelssohn, che trattavano la bellezza come gli entomologi trattano le farfalle.
Quella di Hamann, dice Berlin, è la reazioni tipica dei romantici degli anni Settanta contro la tendenza dei francesi a generalizzare, a classificare, a infilzare, a sistemare in album, a sforzarsi di produrre un qualche tipo di ordinamento razionale dell’esperienza umana, lasciando fuori l’élan vital, il flusso, l’individualità, il desiderio di creare, il desiderio, perché no?, di lottare, quell’aspetto degli esseri umani che produce il creativo scontro di opinioni tra persone che la pensano diversamente, anziché quella morta armonia e quella morta pace di cui, secondo Hamann e i suoi seguaci, i francesi vanno in cerca. Reazione contro collezionisti di farfalle e classificatori seriali, dei quali, quasi un secolo dopo Hamann, Flaubert si prenderà gioco, in uno scherzo che non doveva avere fine.
Hamann contesta l’illuminismo più tenacemente di quanto farà, per esempio, Stirner. Non ci sono concetti generali. L’idea stessa di far rientrare due cose nello stesso genere è improponibile. L’idea che qualcosa, una poesia, pensata in una lingua, possa essere espressa in un’altra, è una sciocchezza. Secondo Hamann, dice Berlin, un’idea del genere è pura follia. La lingua è il mezzo attraverso il quale esprimiamo noi stessi. Da un lato non c’è il pensiero, e dall’altro la lingua. La lingua non è un guanto che infiliamo sul nostro pensiero. Quando pensiamo, pensiamo in simboli, pensiamo in parole, e ogni traduzione è dunque in linea di principio impossibile.
Il tentativo di tradurre la lingua usata da un uomo in un’altra lingua, di classificare tutti i suoi vari movimenti mediante un metro anatomico o fisiognomico, di collocarlo in una casella insieme con un mucchio di altra gente e di produrre un dotto volume che si limiterà a etichettarlo come un esemplare di una specie, di un tipo: tutto ciò, dice Berlin, significa fallire ogni conoscenza, significa uccidere, significa applicare concetti e categorie – contenitori vuoti – alla carne palpitante, unica, asimmetrica, inclassificabile della vivente esperienza umana. Le parole fanno a pezzi le cose. Le parole, dice, classificano, le parole sono troppo razionali. Il tentativo di raccogliere le cose in caselle ben definite e di ordinarle in una maniera meravigliosamente analitica distrugge l’unità, la continuità e la vitalità dell’oggetto.
Ciò che è reale non è razionale. Reale è il conflitto, la collisione, la tragedia, la morte.
In Hamann, dice Berlin, affiora l’intera costellazione dostoevskiana.
V
Tutto questo mondo brulicante di forze e contro forze, e il suo racconto, che non è lo specchio di un mondo statico là fuori, ma è un frammento di movimento, esso stesso in movimento, è ciò che gli uomini hanno fatto di esso. Il nostro mondo, il nostro mondo tedesco, dice Berlin, è l’opera di altri tedeschi, e a ciò si deve se al nostro odorato, al nostro tatto, al nostro sguardo e al nostro orecchio appare come appare. La nozione dell’essere a casa propria (heimlich), o dell’esser tagliati fuori dalle proprie naturali radici (unheimlich), l’idea di radici, l’idea dell’appartenenza a un gruppo, a una setta, a un movimento, furono in buona parte un’invenzione di Herder.
Herder, dice Berlin, non usa il criterio del sangue, e neppure quello della razza. Parla della nazione, ma nel Settecento la parola tedesca Nation non aveva la connotazione che «nazione» acquistò nel corso dell’Ottocento. Egli parla della lingua come di un legame, parla del suolo come di un legame, e la sua tesi è grosso modo questa: ciò che le persone che appartengono allo stesso gruppo hanno in comune è più direttamente responsabile del loro essere che non ciò che hanno in comune con gli uomini che vivono in altri luoghi.
Con Herder, dice Berlin, comincia a prendere forma la nozione di storicismo, di evoluzionismo, la nozione secondo la quale puoi capire altri esseri umani soltanto nel contesto di un ambiente che sarà molto diverso dal tuo. Sta qui anche la radice della nozione di appartenenza. Herder è in effetti il primo a definire con chiarezza tale nozione, e proprio per questo l’idea dell’uomo cosmopolita, ossia di un uomo che si sente egualmente a casa sua a Parigi, o a Copenaghen, o in Islanda, o in India, gli riesce repellente. Un uomo appartiene al luogo in cui vive, dice, gli uomini hanno radici, essi possono creare soltanto all’interno dei simboli in cui sono stati allevati, e ciascuno è stato allevato entro una società chiusa che ha parlato a lui in una maniera assolutamente peculiare, unica.
Quella di Herder, dice Berlin, era una dottrina che i cosmopolitici pensatori razionalisti, universalisti, oggettivisti del Settecento francese non avrebbero potuto capire, e che sicuramente non avrebbero mai potuto approvare.
Se c’è qualcosa che Herder detesta, dice, è l’eliminazione di una cultura da parte di un’altra. Non gli piace Giulio Cesare perché ha calpestato un gran numero di culture asiatiche, col risultato che non sapremo mai di che cosa andavano in cerca gli abitanti della Cappadocia. Non gli piacciono le Crociate perché hanno danneggiato i bizantini, o gli arabi. Detesta ogni forma di violenza e di coercizione, e l’assorbimento di una cultura da parte di un’altra cultura, perché vuole che ogni cosa sia quella che è nella misura più completa possibile.
In altre parole, dice Berlin, è il capostipite di tutti quegli antiquari i quali vogliono che gli indigeni rimangano quanto più indigeni possibile, che amano le arti e i mestieri, che detestano l’omologazione. Insomma, dice Berlin, Herder è il capostipite di tutti coloro che amano ciò che è curioso, coloro che vogliono preservare le più squisite forme di vecchio provincialismo, senza interferenze da parte di qualche odiosa uniformità metropolitana. Herder è il padre, l’antenato di tutti quei viaggiatori, di tutti quei dilettanti che girano il mondo portando alla luce ogni specie di forme di vita dimenticate, compiacendosi di tutto ciò che è peculiare, di tutto ciò che è singolare, di tutto ciò che è indigeno, di tutto ciò che è intatto.
Non si può certamente ritenere Herder responsabile di tutti quelli che si sono convertiti dall’astronomia all’astrologia, e consultano oroscopi e cartomanti come una volta si consultavano i manuali di sociologia e gli psichiatri, o di quelli che si abbuffano di cinchona succirubra o semi di origano per combattere il cancro, o di quelli che credono nelle scie chimiche o che la terra sia piatta, o di quelli che rinunciano ai vaccini e si curano con le bacche di goji, o di quelli che credono che la differenza tra uomo e donna giustifichi la relegazione di quest’ultima alla procreazione, o che la donna è terra, mentre l’umo è cielo, che la donna è madre e pace e l’uomo fuco e guerra, e stronzate simili, di quelli che hanno cambiato Marx con Carnacina, di quelli che credono che i diversi vanno rispettati, anche quando hanno torto marcio, che il diverso è ricchezza e va preservato, aiutato e accolto, anche quando questo diverso ti toglie l’aria che respiri, eccetera. Non si può ritenere Herder responsabile di tutto questo, ma certo egli ha contribuito a che tutto ciò accadesse.
Herder, dice Berlin, piantò un pugnale nel corpo del razionalismo europeo, infliggendogli un colpo terribile da cui non si è mai più ripreso.
VI
Il romanticismo è il trionfo della storia sulla sostanza e sulle verità eterne, è il trionfo delle differenze sul pensiero unico. C’è storia proprio in quanto ci sono differenze che si oppongo e si rintuzzano. Se non ci si fossero differenze, tutto sarebbe contratto in un punto. Non stupisce, pertanto, che nel romanticismo si trovi l’esaltazione di tutto e del suo contrario, che il romanticismo abbia una corrente reazionaria, persino fascista, e una corrente progressista, di sinistra, persino rivoluzionaria.
Non deve sorprendere che nel romanticismo, dice Berlin, ci siano contemporaneamente due cose così contraddittorie come, da un lato, il nobile selvaggio, il primitivismo, la vita semplice, i contadini dalle guance rosse, l’abbandono della spaventevole raffinatezza delle città in favore delle ridenti praterie degli Stati Uniti, o qualche altra semplice forma di vita in un’altra parte del globo, reale o immaginaria, e, dall’altro, le parrucche azzurre, le chiome verdi, l’assenzio e Gérard de Nerval che porta a spasso la sua aragosta nelle strade di Parigi per attirare un po’ d’attenzione su di sé (riuscendoci). Se, dice, ci domandiamo che cosa hanno in comune questi due atteggiamenti, la risposta è che entrambi vogliono mandare in pezzi la lo stato delle cose presenti.
Naturalmente, dice Berlin, se penso di poter diventare davvero un nobile selvaggio, se penso di potere davvero trasformarmi in un semplice indigeno di un qualche paese non civilizzato, che vive una vita molto primitiva, la magia si dissolve. Ma nessuno dei romantici lo pensava – dice. L’essenza della visione romantica del nobile selvaggio sta nell’irraggiungibilità della meta. Se fosse stata raggiungibile, la figura del nobile selvaggio sarebbe stata inutile, perché sarebbe diventata un qualcosa di orribilmente dato, una spaventevole regola di vita, non meno vincolante, disciplinante e detestabile di quella che sostituiva. Il nocciolo della faccenda è dunque ciò, che è impossibile trovare l’inattingibile, l’infinito.
Sei i nemici sono lontani, se i nemici sono «loro», se il nemico è il Potere, o poteri invisibili, oscuri, nascosti, il momento della decisione, il momento di alzare il culo e chiedersi cosa fare, qui, adesso, non arriva mai.